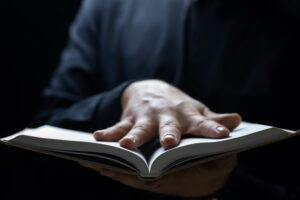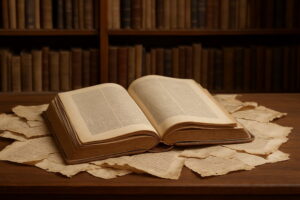L’anno 1919 emerge dalle ceneri di una guerra devastante: nelle fabbriche italiane ancora annerite dal fumo delle caldaie, il sudore e la fatica definiscono il ritmo dell’esistenza. In quel contesto di lavoro estenuante, dove le dodici ore giornaliere costituivano la norma, si consumò una svolta epocale: il 20 novembre 1919, la FIOM, Federazione Impiegati Operai Metallurgici, sotto la guida del sindacalista Bruno Buozzi, siglò un accordo storico con l’Associazione degli Industriali Metallurgici di Milano. Per la prima volta, si sanciva ufficialmente il diritto a una giornata lavorativa non più di dodici ore, ma di otto. Quella che fu una vera e propria rivoluzione, conquistata attraverso scioperi, proteste e una crescente consapevolezza, riconobbe l’operaio non più come mero ingranaggio, ma come essere umano. Con quel patto fondamentale si gettarono le basi del concetto moderno di lavoro, inteso non solo come traguardo, ma come un imprescindibile punto di partenza per l’evoluzione sociale.
Sono trascorsi oltre cento anni. Questo secolo è stato travolto da rivoluzioni tecnologiche che hanno sovvertito ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Le catene di montaggio meccaniche sono state soppiantate dalla robotica, i farraginosi registri cartacei hanno ceduto il passo a software sempre più rapidi ed efficienti e la battitura a macchina delle segretarie è stata sostituita da gestionali informatici che elaborano fatture, inviano ordini e incassano telematicamente. Oggi, la stipula di contratti e l’invio di merce a livello globale, con consegne che si completano in poche ore, richiedono talvolta un semplice comando vocale. L’avvento dell’intelligenza artificiale (IA) ha condensato in pochi minuti attività che un tempo esigevano ore, giorni o l’impiego di intere squadre di lavoro.
Dall’acciaio al silicio: l’evoluzione della produttività
Eppure, malgrado questa produttività aumentata in maniera esponenziale, ci ritroviamo ancorati al medesimo modello temporale. Lavoriamo ancora otto ore al giorno, come se il progresso fosse rimasto inerte, come se fossimo tuttora legati ai ritmi esatti del carbone e delle officine meccaniche del primo Novecento. È un paradosso stridente, paragonabile al vivere in un’abitazione dotata di lavatrice, ma persistere nel lavare i panni al fiume. Se nel 1919 la riduzione dell’orario lavorativo era un gesto audace, progressista e rivoluzionario, oggi, nel pieno fulgore dell’era digitale, la coerenza evolutiva imporrebbe ben altro.
Otto ore ieri, otto ore oggi: il cortocircuito del progresso
La logica del progresso, disancorata da schemi mentali obsoleti, suggerirebbe una giornata lavorativa di quattro ore e forse non tutti i giorni. Questa non è una rivendicazione di pigrizia, bensì una conseguenza di buon senso, una normale evoluzione dettata dalla giustizia sociale. Il mantenimento ostinato di un modello produttivo centenario non ha più alcuna giustificazione razionale se non quella di perpetuare un sistema fondato sulla dipendenza anziché sulla libertà. Il tempo liberato dall’efficienza tecnologica, infatti, non è stato restituito alla collettività.
L’ingranaggio dell’evoluzione sembra essersi ingrippato in un punto non meglio definito. Si continua a operare per otto ore come se tale durata fosse una condizione naturale, giusta e ineluttabile, quasi imposta per decreto. È il trionfo di una mentalità perversamente travestita da normalità. Se un secolo fa si combatteva per ridurre le ore, oggi la vera lotta, dimenticata, dovrebbe essere quella per superare e non conservare, il modello ereditato. La questione fondamentale non è se possiamo permetterci di lavorare meno, ma perché diavolo non lo stiamo già facendo.
In questo contesto di inerzia, la rappresentanza sindacale moderna appare anch’essa in crisi. Dopo oltre un secolo, i sindacati accettano compromessi al ribasso, sottoscrivono accordi di valore infimo (€5) e ignorano totalmente i nuovi comparti lavorativi privi di tutele, come i rider, i precari e i freelance digitali.
Sindacati 2.0: la resa degli eredi di Buozzi
Le conseguenze sociali di questo immobilismo si manifestano chiaramente: mentre gli Italiani faticano a fare figli perché non in grado di mantenerli, si assiste all’importazione di stranieri che procreano poiché vengono mantenuti dagli italiani.
Oggi, si stima che la rappresentanza sindacale sia la peggiore di sempre. I massimi esponenti, descritti come supremi parassiti con stipendi da Nababbi, sono anche ritenuti supremi incompetenti, da decenni arroccati allo strapotere della sinistra al fine di difendere i propri iniqui privilegi e proteggere gli assenteisti e i vili affaristi. Non sorprende che le iscrizioni ai sindacati siano in calo, nonostante si registri una presunta leggera ripresa soprattutto tra i giovani e i migranti.
Aggiungendo ulteriore peso alla precarietà, non solo si continuano a lavorare le canoniche otto ore, ma l’età pensionabile si innalza costantemente. Le otto ore si traducono in quaranta ore settimanali, centosettanta ore mensili, duemila ore annuali, in un ciclo incessante di anno dopo anno.
Considerando la genesi della rappresentanza operaia – dalla CGIL nata nel 1906, influenzata da PC e PSI, fino alla nascita di CISL e UIL nel 1950 e ai successivi UGL, USB, Cobas, eccetera – si giunge a un dato sorprendente: ad oggi, tra sigle settoriali, autonome e di base, l’Italia conta 193 sindacati ufficiali, cui si aggiungono circa tre o quattrocento sigle autonome locali. Si stima che questo vasto apparato sia gestito da 70.000 sindacalisti.
Settantamila eroi stipendiati (e nessuno in officina)
Questo apparato di difensori, per giunta, viene stipendiato dal datore di lavoro per il tempo impiegato a difendere il dipendente. Nonostante non si voglia sminuire l’importanza delle conquiste sindacali degli ultimi cinquant’anni (sebbene il loro ricordo risulti vago), l’attuale stasi sembra aver tradito l’eredità del 1919 e infatti scendono in piazza un po’ per tutto specie se è venerdì.
Pare – magari solo a me – che oggi i sindacati esistano per dare ragione a della gente che ha torto e, se i tuoi figli non sono riusciti a leggere questo pezzo, capendolo, ringrazia i sindacati degli insegnanti.