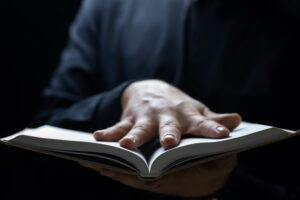L’esame della traiettoria semantica del termine “normale” rivela, attraverso una diacronica osservazione, oscillazioni significative nel suo impiego e nella sua percezione collettiva, delineando un panorama di costante ridefinizione. Se in epoche passate la sua adozione per caratterizzare e talvolta persino stigmatizzare, una condizione percepita come poco attrattiva, quasi da evitare era ampiamente diffusa, è altresì vero che raramente, se non mai, ci si è spinti a un’affermazione enfatica quale “normale è bello”.
Mutazioni nel panorama comportamentale contemporaneo
L’odierno panorama comportamentale, specialmente quello che emerge dalla gioventù contemporanea, impone una riflessione approfondita e pressante, poiché il significato e la desiderabilità della normalità sembrano aver subito una mutazione paradigmatica.
È opportuno rammentare, a tal proposito, il celebre aforisma basagliano, un monito epistemologico affisso sugli edifici dell’ex manicomio di San Giovanni, quel luogo divenuto simbolo della “liberazione” della follia grazie all’opera di Franco Basaglia e della sua équipe. La frase risuonava con una risolutezza disarmante: “Da vicino nessuno è normale”. Tale locuzione, lungi dall’essere una mera provocazione o un atto di sfida intellettuale, configurava un invito perentorio a una disamina introspettiva, un’esortazione a scrutare la propria essenza al di là delle preconcette categorie sociali e delle auto-percezioni illusorie. Suggeriva che la nozione stessa di “normale” è intrinsecamente fallace e non si applica universalmente, nemmeno a coloro che con supponenza si autodefiniscono tali, proiettando sugli altri l’ombra della devianza.
Normalità come traguardo sfuggente
Ancora oggi, a dispetto delle incessanti mutazioni socioculturali, la propensione a riconoscere la normalità come un traguardo auspicabile e un valore da perseguire appare problematicamente elusiva. Persiste, in tutta la sua validità e attualità, l’acume di tale slogan come viatico irrinunciabile per la salute mentale individuale e, per estensione, per l’equilibrio della collettività. Chi, d’altronde, desidererebbe considerarsi un “normale” nel senso più stretto di “normalizzato”, di ridotto a una condizione di anonima omologazione? E chi di noi, se venisse caricata sulle proprie spalle l’onerosa camicia della diversità, anelerebbe a limitarsi a rientrare in un alveo di ordinarietà predefinita?
La brama di distinzione e il declino della normalità
Eppure, in antitesi a questa perenne scetticità e resistenza all’omologazione, si manifesta un slittamento paradigmatico di proporzioni non trascurabili. L’osservazione capillare e il proliferare di episodi quotidiani sembrano raccontarci un’altra storia, una narrazione culturale in cui l’anelito all’unicità, la brama di distinzione e il desiderio impellente di essere riconosciuti come “diversi” sono divenuti tratti caratteristici e preminenti dell’identità contemporanea. Questo anelito ostinato alla distinzione ha progressivamente e inesorabilmente relegato la normalità a una qualità di scarsa rilevanza, quasi evanescente, una quantità trascurabile nell’economia del prestigio sociale e dell’interesse collettivo.
Normalità come sinonimo di banalità
La normalità è ora percepita come tediosa, persino da rifuggire come una condizione intrinsecamente negativa, un mero sinonimo di banalità. Questo giudizio non è solo esterno, un’etichetta apposta dagli altri, ma – e qui risiede il peggio, la disfunzione più acuta – è spesso internalizzato dagli stessi individui, che di sé stessi pensano, o temono, di essere “normali”.
La “diversità” cui si anela, tuttavia, si rivela spesso essere una “maschera” artificiosa, un costrutto effimero e premeditato, piuttosto che un’autentica espressione di individualità. Essa è adoperata da una vasta schiera di adolescenti – e non di rado anche da adulti – come strategia calcolata per distinguersi nella folla, per catalizzare l’interesse altrui, o per suscitare sorpresa e, idealmente, ammirazione nell’ambiente circostante. Si tratta, in sostanza, di un artificio sofisticato, quasi un stratagemma scenico e un trucco retorico, volto a eludere la percezione di banalità e l’omologazione che si ritiene derivi dalla conformità alla normalità. Questa rappresentazione artificiosa e talvolta esasperata del sé non è, in ultima analisi che un palliativo per una crisi d’identità profonda e strutturale, un tentativo disperato di “chiudere almeno un po’”, una ferita esistenziale che stenta a rimarginarsi: nella foga di essere “diversi”, spesso si finisce per conformarsi alla più comune delle inautenticità.
La scuola come teatro della diversità
L’ambiente scolastico, in questo contesto di perpetua ricerca di unicità, offre un’eloquente e drammatica esemplificazione di tale fenomeno erigendosi a “teatro a sipario sempre aperto” dove si inscena quotidianamente questa complessa commedia umana.
Dalle manifestazioni di bullismo, espressione deviata di una ricerca di potere e riconoscimento, alle eccentricità estetiche più peculiari, ogni gesto, ogni scelta esteriore, diviene una performance, un tentativo di affermare una “diversità” spesso vuota di contenuto autentico.
Analogamentee in una dimensione più amplificata e globalizzata, nel mondo appariscente dello sport professionistico – si pensi emblematicamente al gioco del calcio, ma il fenomeno è pervasivo e diffuso un po’ dappertutto – la pratica del tatuaggio è intrinsecamente e massivamente correlata a questa auto-rappresentazione ostentata, a questa brama di distinguersi visivamente. Tale tendenza è alimentata e incentivata da un fenomeno epocale, la spettacolarizzazione pervasiva dell’immagine individuale attraverso i mezzi di comunicazione di massa, quali la televisione e le onnipresenti pratiche mediatiche digitali che trasformano l’individuo in un simulacro da esibire e consumare, in una perpetua ricerca di visibilità.
Il destino della normalità
Ma quale destino incombe sulla normalità in questo contesto di incessante esibizione e ricerca di distinzione? Il suo significato e la sua valenza intrinseca subiscono uno slittamento meno evidente, ma forse ancor più pregnante e problematico. Da un lato essa sembra soffocata e quasi estinta, una presenza ectoplasmatica nel panorama sociale equiparata a “une quantité négligeable”, ovvero qualcosa di socialmente irrilevante, trascurabile, privo di peso specifico. È letteralmente scomparsa dalla circolazione concettuale, priva di interesse per la collettività e di risonanza nell’immaginario contemporaneo. Si ha l’impressione che, sovraccarichi e obnubilati da una proliferazione incontrollata di false rappresentazioni del sé e del mondo, abbiamo irrimediabilmente perduto qualsiasi discernimento di cosa possa costituire “il normale” per noi stessi, per la nostra intima essenza.
Paradossalmente, proprio questa eclissi e questa perdita di contorni potrebbero e forse dovrebbero elevarla al rango di risorsa preziosa da riguadagnare, un bene da riscoprire nella sua autenticità e nella sua funzione equilibratrice.
L’assurdità di imparare a essere normale
La nozione di dover “imparare a essere normali” si configura, infatti, come una palese assurdità, una contraddizione in termini che sfida la logica e l’esperienza umana. È pressoché inconcepibile immaginare uno scenario in cui un genitore, con la serietà di un precettore, istruisca il proprio figlio su una tale “banalità”, o che si mettano a punto “strumenti di sapere pratico” per insegnare una simile ovvietà esistenziale.
Non si riesce davvero a figurarsi un padre o una madre che prenda da parte il figlio e gli dica: “Adesso provo a insegnarti a essere normale”. Forse, un nonno, con la saggezza dell’età e un approccio meno performativo, potrebbe tentare di comunicare qualcosa su questo tema, sebbene il suo messaggio rischierebbe di trovare poca eco in un nipote che anela a tutto tranne che all’esortazione a conformarsi all’omologazione.
I giovani, animati da un’inestinguibile brama di affermazione, aspirano ardentemente a essere “qualcuno”, a distinguersi nella spietata competizione sociale che li circonda, rifiutando con veemenza l’anonimato e la mediocrità percepita. Il desiderio di essere “uno qualunque in mezzo a tanti altrettanto anonimi” è non solo estraneo, ma antitetico alla loro volontà intrinseca di affermazione individuale e di riconoscimento.
La normalità come esigenza ineludibile
Eppure, questa normalità, sebbene sia spesso misconosciuta e percepita come un “sacco vuoto e inutile”, suscita un’esigenza intrinseca e insopprimibile di essere riempita di significato.
Sebbene la sua supposta inutilità possa e debba essere oggetto di profonda messa in discussione, la comprensione di tale esigenza è palpabile, una sensazione diffusa che permea la collettività, un presentimento che quel contenitore non sia affatto da scartare.
È interessante e forse provvidenziale notare come, persino all’interno del contesto scolastico attuale, un ambiente così marcatamente meritocratico, competitivo e orientato alla performance, si stiano timidamente avviando discussioni e riflessioni volte a riabilitare e a riscoprire il valore intrinseco della normalità, non più come conformismo passivo o assenza di peculiarità, ma come fondamento autentico e saldo dell’identità individuale e collettiva, una base indispensabile per un benessere psicologico e sociale più profondo.