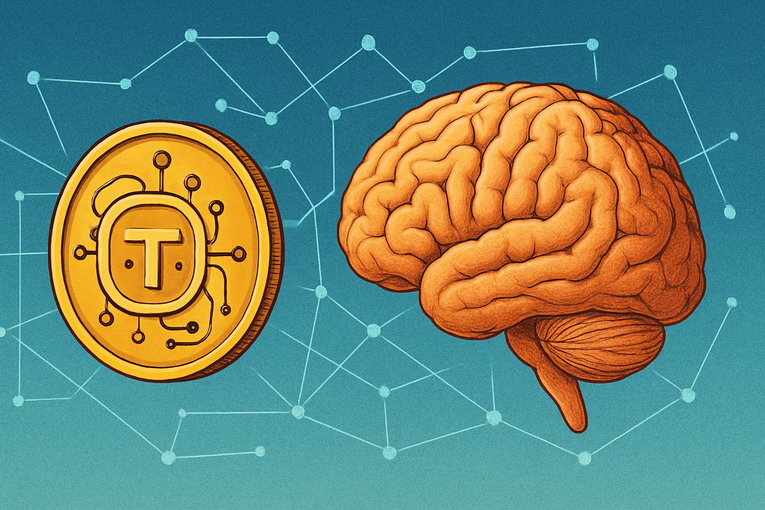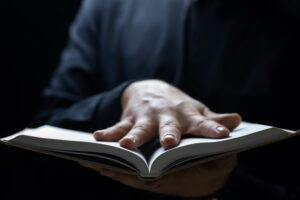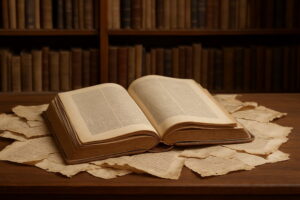Il lavoro della mente è sempre stato un oggetto misterioso per la filosofia. Georg Simmel, nel suo sguardo sulla modernità, ha suggerito che la produzione dell’intelletto fonde corpo e spirito in una corrente invisibile, che si dissolve nel risultato finale—una tradizione di pensiero che resiste al tentativo di misurazione. Eppure, oggi più che mai, ci interroghiamo su come assegnare valore ai frammenti prodotti da scrittori e consulenti, giornalisti e docenti: idee, intuizioni, segmenti di senso che sfuggono alla contabilità del mercato e sopravvivono nella nebbia di tempo, reputazione, prestigio accumulato.
Il valore invisibile delle idee
Ogni volta che un avvocato scolpisce il destino di una causa attraverso semplici clausole contrattuali, un ricercatore distilla intuizioni in lunghi mesi di studio o un consulente comprime giorni di pensiero in poche slide, assistiamo allo stesso enigma: il valore del lavoro intellettuale sembra risiedere in un fluido invisibile. Scriviamo, argomentiamo, innoviamo—ma nessuno conta, davvero, le particelle di pensiero che mettiamo in circolo. Paghiamo per la firma, per la giornata, per lo status; ignoriamo la matematica dei micro-valori che si nascondono sotto la superficie.
La rivoluzione dei token
L’AI, invece, rovescia il tavolo. Con la sua logica di token, dissolve la nebbia e impone una contabilità atomica: ogni parola diventa un’unità misurabile, ogni sillaba un frammento di valore, ogni input un costo esplicito. Ogni volta che interagiamo con un chatbot o chiediamo a un modello di scrivere un testo, paghiamo un pedaggio invisibile: i token. È il prezzo molecolare della conoscenza.
Tra filosofia e tecnologia
Qui la tecnologia si intreccia con la filosofia, mettendo in scena quel meccanismo che Wittgenstein chiamava “proposizione elementare”—atomo di senso capace di rappresentare uno stato del mondo. Gregory Bateson avrebbe aggiunto: “L’informazione è una differenza che crea differenza.” L’AI non fa altro che rendere visibile questa dinamica, monetizzando ogni piccolo scarto linguistico.
Un mercato già in frammenti
E non è del tutto nuovo. I giornalisti digitali vengono pagati a click, i traduttori a parola, i copywriter a carattere. Il mercato, insomma, flirta da tempo con l’idea di una retribuzione atomica, ma lo fa senza convinzione, come fosse solo un sintomo di squilibri temporanei. L’intelligenza artificiale, invece, istituzionalizza ciò che il sistema umano ha sempre esitato a normalizzare: porta la frammentazione a norma, trasformando ogni eco di pensiero in una voce di bilancio.
Il rischio della contabilità della creatività
La tentazione di applicare un modello “a token” alle persone potrebbe sembrare seducente, capace di portare trasparenza e giustizia. Ma a quale prezzo? Se il criterio premiato fosse solo la quantità, lo scrittore inseguirebbe il conto delle parole, il consulente la densità di slide, il professore la somma di “crediti semantici”. L’innovazione rischierebbe di piegarsi a una logica fordista, in cui la creatività diventa processo meccanico, e la differenza si perde nelle maglie del conteggio.
Lo specchio che ci tende l’intelligenza artificiale
Alla fine, il vero effetto filosofico dell’AI non si gioca solo sul piano tecnologico ma su quello speculare. Ci obbliga a guardare noi stessi, a capire che anche il pensiero umano è, da sempre, una sequenza di micro-eventi cognitivi. Abbiamo sempre preferito ignorare questo scontrino invisibile che la nostra mente emette ogni giorno. L’AI ce lo mette sotto gli occhi e ci chiede: siamo pronti a riconoscere e dare il giusto prezzo al lavoro invisibile della mente, oppure accetteremo di ridurlo a una collezione di token—frammenti da consumare e contabilizzare, dimenticando la sua origine creativa?