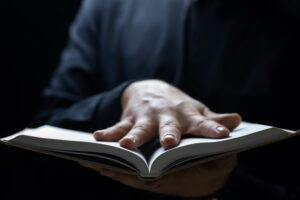L’epoca attuale, pervasa dall’iperconnessione e dalla promessa di un accesso illimitato al sapere, è nondimeno insidiata da una criticità sociale di crescente portata: l’analfabetismo di ritorno. Questo fenomeno non attesta l’ignoranza primigenia di chi non ha mai decifrato segni grafici, bensì la tragica regressione di individui che, pur avendo acquisito le competenze basilari, le hanno lasciate atrofizzare, cedendo all’oblio e alla superficialità. Non si tratta, pertanto, di una mera perdita della capacità di decodifica, ma di una progressiva erosione del pensiero critico, della rinuncia alla complessità intellettuale e di un preoccupante appiattimento del linguaggio. Abbiamo superato l’analfabetismo linguistico, ma ci troviamo impreparati dinanzi alla sfida ben più insidiosa dell’analfabetismo funzionale.
Un’Italia che fatica a comprendere
I dati emersi dalla ricerca sulle “Competenze degli Adulti” (OECD/INAPP) delineano un quadro allarmante: il 35% degli adulti italiani nella fascia d’età 16-65 anni manifesta la capacità di comprendere esclusivamente frasi brevi e semplici. Tali individui non sono in grado di interpretare testi articolati, di lunghezza superiore a una pagina, nè di decifrare statistiche o grafici complessi, una percentuale che supera sensibilmente la media degli altri Paesi dell’Unione Europea (26%).
Effettuando una stima, ciò si traduce in circa 13 milioni di persone in Italia incapaci di analizzare dati, testi o concetti di natura complessa. Il corollario di tale dinamica è gravissimo: queste persone non sono in grado di formulare un’opinione autonoma, di immaginare scenari non preconfezionati o di esercitare una valutazione critica sulle idee altrui. L’analfabetismo di ritorno si configura come una forma di auto-mutilazione intellettuale, l’accettazione passiva di un universo in cui le informazioni sono somministrate massivamente senza richiedere alcuno sforzo interpretativo.
Il paradosso dell’era digitale
Viviamo schiacciati da un sovraccarico informativo che l’individuo non è più in grado di filtrare, gestire o elaborare. Il paradosso della società globalista e tecnologica è che l’incremento esponenziale delle informazioni disponibili coincide con la labilità della nostra conoscenza. In tale contesto, una responsabilità significativa è attribuita alla diffusione pervasiva di smartphone e social network, ambienti in cui la brevità dei testi e dell’attenzione tende a generare un “cervello a breve raggio“.
La filosofia, da sempre, esorta all’interrogazione sul significato dell’esistenza e sulla natura del reale. E tuttavia, ci si interroga: “come possiamo porre domande profonde se il nostro stesso strumento di indagine, il linguaggio, si è ridotto a un balbettio digitale?”.
Si smarrisce così la facoltà di discernere il significativo dal banale, il vero dal falso, non potendo più cogliere le sfumature o leggere tra le righe.
Un popolo manipolabile e vulnerabile
Questa piaga non si limita alla sfera individuale, bensì si allarga al tessuto sociale. Una collettività composta prevalentemente da analfabeti funzionali è intrinsecamente vulnerabile e manipolabile, incapace di affrontare le sfide imminenti. Tale società si affida ciecamente a semplificazioni grossolane, a slogan vuoti e a leader carismatici.
Si solleva il quesito – evitando l’abbraccio di teorie complottistiche – se l’èlite politica conservi un interesse concreto nell’innalzare il livello culturale medio, giacchè un cittadino scarsamente istruito è più agevolmente influenzabile nelle sue scelte, sia nel consumo di beni superflui che nella selezione di figure politiche anche dannose per il bene comune. A tale scenario contribuisce anche il sistema educativo, dove le scuole, sempre più assimilate a imprese il cui finanziamento è legato al numero degli iscritti, misurano il successo prevalentemente attraverso gli indici di promozione o i voti d’esame. Tali indicatori non sempre riflettono l’effettiva preparazione, mentre si moltiplicano gli Open Day come campagne pubblicitarie per acquisire nuovi “clienti” e si assiste a un incremento di certificazioni che possono influenzare la promozione indipendentemente dal reale rendimento scolastico. Gli insegnanti, d’altra parte, sono gravati da una crescente mole burocratica e da progetti spesso finalizzati al ritorno economico dell’istituto.
La necessità di una rinascita culturale
Nondimeno, l’analfabetismo di ritorno non costituisce un fato ineluttabile. È un imperativo morale e sociale riappropriarsi della ricchezza semantica del linguaggio, riscoprire la profonda voluttà della lettura e coltivare uno spirito critico e autonomo. Dobbiamo cercare tutte le possibili modalità affinchè si possano educare le future generazioni al valore inestimabile della conoscenza, all’intrinseca bellezza della complessità e alla vitale necessità di interrogare il mondo senza accettare nulla come scontato.
Questa è davvero la sfida che deve essere vinta, non solo per preservare la nostra umanità, ma per edificare un futuro autenticamente democratico, ove la conoscenza sia accessibile nella sua essenza profonda e trasformativa.
È pertanto necessario tornare a leggere, non solo le parole vergate, ma il mondo stesso, con occhi attenti e curiosi, capaci di cogliere la complessità e la bellezza spesso occultate sotto la superficie dell’ovvio. Soltanto in tal modo potremo attestare di essere alfabetizzati pienamente, non solo formalmente, ma nel cuore e nella mente, raggiungendo quella consapevolezza che ci rende integralmente umani e cittadini attivi.