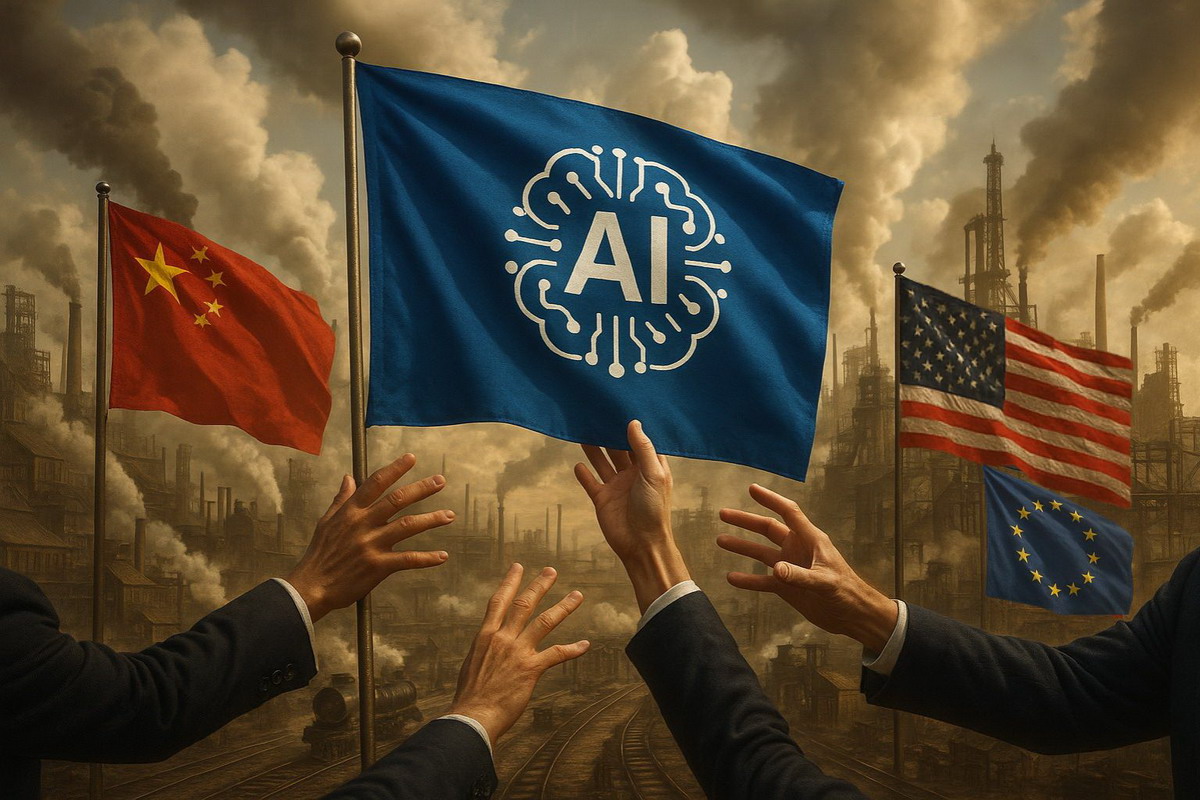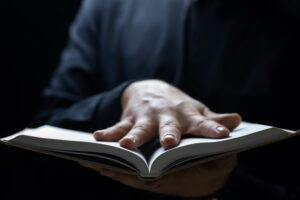L’intelligenza artificiale oggi è la più potente architettura di potere che l’Occidente abbia conosciuto dalla Seconda Rivoluzione Industriale. Non è tecnologia neutrale: è nuova grammatica di politica industriale, ridisegna filiere, disarticola alleanze, sovverte le gerarchie del lavoro e introduce una contabilità sommersa ma concretissima della ricchezza delle nazioni. Gli Stati Uniti lo hanno intuito subito, scegliendo una via mercantil‑statale che intreccia infrastrutture materiali, dominio degli standard, tecnodiplomazia e difesa sotto il segno di un potere centrale che decide e orchestra. La Cina, da vent’anni, fonde la «razza delle macchine» allo Stato profondo. L’Europa, invece, oscilla tra normativismo morale e sotto‑investimento in ciò che conta: energia, calcolo, industria, ricerca. Norme ovunque, cantieri quasi nessuno: il culto delle procedure ha sostituito la volontà di incidere.
Il programma statunitense
L’AI americana, come si legge nel recente Action Plan dell’amministrazione USA, è un programma di potenza, non un esercizio di estetica tecnica: una chiamata alle armi dell’economia politica. L’agenda è tutta atti amministrativi, deregulation selettiva, mercati del calcolo, modelli pronti all’acquisto pubblico per la Pubblica Amministrazione. La cultura dominante è pragmatismo fordista: costruire, misurare, scalare – e ricominciare da capo. È il ritorno del capitalismo politico: lo Stato comanda la direzione dell’innovazione, il privato la esegue, la difesa scandisce tempi e priorità.
Tecnodiplomazia e standard
I data center e la rete elettrica sono asset geopolitici, la filiera dei semiconduttori viene «riseminata» in patria o assicurata con alleanze d’acciaio. La diplomazia si fa tecnodiplomazia: si esporta l’intero stack dell’AI agli alleati, si fissano standard e regole d’uso, si irrigidiscono i controlli all’export per chiudere ogni varco ai rivali strategici. Non è egemonia che grida, ma che accumula: la logica del benchmark scalza quella della legge. Chi decide i formati, i protocolli di audit, i vincoli di sicurezza, finisce per rendere sostituibili gli altri e imprescindibile sé stesso.
Materia e cultura del dominio
La materia del potere non basta: conta la cultura che la abita. Le catene del valore diventano dipendenza, e la metallurgia del potere — chip, terre rare, litio, rame, soprattutto energia — non ammette sconti di realtà. Senza corrente e computazione ogni retorica su AI evapora. Ma il dominio non si limita alla fisica delle infrastrutture: i modelli sono architetture linguistiche che delimitano l’universo del dicibile. Chi li governa traccia, in silenzio, il confine di ciò che può essere pensato in burocrazie, imprese e mercati. Non è questione tecnica, ma politica.
Europa: eccellenze disperse
L’Europa vanta eccellenze ma le disperde: governa le cose ignorando gli uomini e così si auto‑condanna. Manca una verità: AI senza strategia energetica è carta straccia. Ne manca una seconda: la PA, che dovrebbe essere traino della domanda, si accontenta di linee guida dove occorrerebbero capitolati AI‑ready in grado di dettare lo standard. Ne manca una terza: la retorica della riqualificazione professionale s’incaglia quando non è sostenuta da fondi solidi e da una contrattazione d’anticipo che riporti potere nei luoghi della produzione.
Finanza e strumenti di politica industriale
Senza risorse vere, ogni strategia è illusione. Gli USA mobilitano centinaia di miliardi fra investitori, acquisti pubblici e capitale di rischio; l’Italia deve esplicitare i meccanismi: fondi UE mirati (Next Generation EU, Horizon), partenariati strutturati pubblico‑privati in cui lo Stato mantenga il controllo strategico, ammortamenti accelerati su calcolo ed energia, un fondo sovrano tecnologico — alimentato da CDP e capitali previdenziali — che co‑investa e recuperi rendimenti. Non si dà dirigismo senza risorse, né politica industriale senza strumenti finanziari adeguati.
Standard e sovranità interoperabile
Sul piano degli standard, inseguire non basta. Occorre un framework pubblico di valutazione per robustezza, sicurezza, provenienza del dato e capacità di logging, con laboratori dove PA, industria e accademia testino davvero i modelli in scenari critici. Sobria sovranità interoperabile: allineamento ai migliori framework globali, estensione nazionale su chiavi e audit dei dati sensibili. Il pericolo vero è una dipendenza sistemica da modelli fondazionali esterni: l’Europa rischia di essere solo un mercato per foundation models americani o cinesi, perdendo il controllo sui layer critici. Serve una strategia a tre livelli: foundation models europei settoriali, pooling di risorse tra Stati membri, ingegneria inversa e capacità autonome di validazione nei limiti dell’ordinamento europeo.
Dati e commons
La bussola sui dati dev’essere severa: delimitare con nettezza il perimetro dei dati critici (sanitari, fiscali, giudiziari, infrastrutturali), disegnare architetture che assicurino gestione delle chiavi nelle mani dell’ente titolare e tokenizzazione diffusa, e introdurre confidential computing per tutte le terze parti non pienamente fidate. Commons settoriali trasparenti, con licenze chiare e tracciabilità reale, devono essere la base di una sovranità pragmatica, fatta di qualità istituzionale non di isolamento.
Industria e filiere
L’industria va guidata più che celebrata. Sostenere PMI esportatrici con accesso agevolato a calcolo e competenze, promuovere contratti di sviluppo sull’intera filiera (raffreddamento, sensoristica, sicurezza fisica), prevedere vere clausole di local content nei grandi appalti per rendere esigibile una quota nazionale se l’interesse strategico lo pretende.
Lavoro e corpi intermedi
È sul lavoro che si gioca la rinascita dei corpi intermedi. Senza fondi di transizione ancorati a progetti AI, con formazione certificata, salario di continuità e rotazione effettiva dei ruoli; senza una contrattazione che sancisca diritti algoritmici (spiegabilità, limiti alla sorveglianza) e premi di produttività trasparenti, ogni governance della fabbrica digitale sarà finta. Solo alleanze solide fra scuola e impresa – ITS, università, aziende – creano la massa critica sulle nuove competenze.
Open‑weight: apertura vigilata
Sui modelli open‑weight, la linea dev’essere netta: apertura ampia a ricerca e formazione, uso controllato in applicazioni critiche; obbligo di filtri input/output, watermarking, limiti di traffico, documentazione della natura e dei limiti del modello; responsabilità piena in capo all’integratore, che deve poter dimostrare robustezza e monitoraggio continuo.
Difesa come acceleratore di filiere
La difesa, lungi dall’essere sola voce di costo, è acceleratore di filiere. Serve un Virtual Proving Ground nazionale in cui PA, industria e forze dell’ordine testino insieme la protezione delle infrastrutture, esercitino red teaming, coordinino la lotta alla disinformazione. Da qui origina non solo tecnologia migliore, ma disciplina organizzativa: il vero moltiplicatore del potere.
Postura europea
Finché l’Europa parla a ventisette voci la sua voce non conta. Uscire dall’estetica dell’autoregolamentazione e assumere la grammatica del reale: serve un consorzio europeo sull’energia per data center, una grid continentale — preferibilmente una dorsale HVDC — con corridoi power‑to‑compute e backup reciproco fra poli di calcolo. Gli acquisti pubblici di AI dei Paesi membri valgono decine di miliardi: aggregarli significa trattare alla pari. Una sola voce ai tavoli globali, criteri comuni e standard europei rafforzati su privacy e forensic readiness: così si contratta davvero con i grandi attori mondiali.
Cosa non importare
Tre cose non vanno importate dagli USA: la guerra culturale travestita da neutralità tecnica — i modelli non sono tribunali del vero; l’ipertrofia del «move fast» senza accountability, seminatrice di rischio sistemico e fragilità istituzionale; l’illusione dell’autosufficienza assoluta — l’Europa, per storia, vive di interdipendenze ordinate.
Cadenza operativa e traguardo
Solo la disciplina degli atti sostiene la sovranità. Nei prossimi diciotto mesi si identifichino i siti candidati, si attivi il fast‑track autorizzativo, si pubblichino linee guida rigorose per la PA, si lancino testbed nazionali, si negozino i primi contratti energia‑calcolo. Nei 18–36 mesi si renda davvero operativa la rete dei poli di calcolo e si sviluppino modelli nazionali; in cinque anni l’Italia sia l’hub mediterraneo dell’AI europea, con export tecnologico e bilancia commerciale positiva sull’intelligenza. Una via italiana all’AI non è terza via astratta ma politica economica concreta: ricucitura tra capitale e lavoro, centralità delle infrastrutture e dei corpi intermedi. Il resto, folklore digitale.