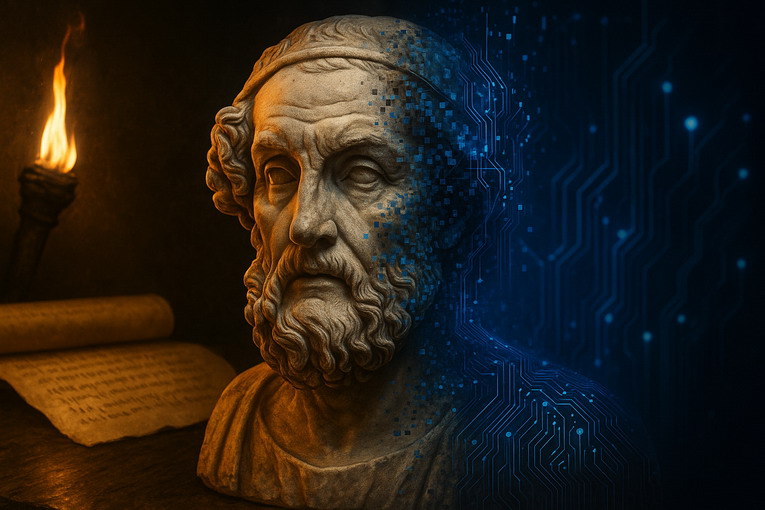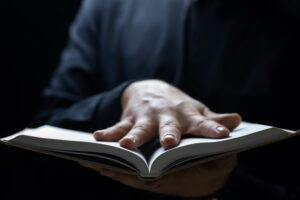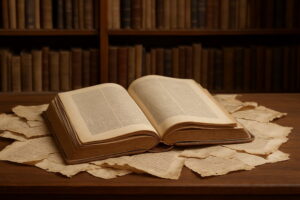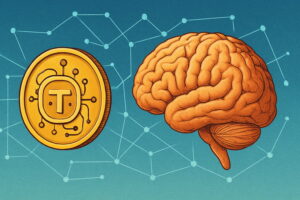La “questione omerica” non è mai stata un mero affare di filologia, quanto una profonda metafora della libertà perché racchiude la tensione eterna che intercorre tra la creazione individuale e quella collettiva, tra il lampo del genio e la seduzione della tradizione, tra il disegno imposto dall’alto e l’ordine che emerge spontaneamente.
Un ordine nato dal disordine
Quando Friedrich August Wolf, nel 1795, osò mettere in discussione l’esistenza di un unico, granitico Omero, lo fece perché quei poemi, l’Iliade e l’Odissea, apparivano troppo vasti e contraddittori per essere l’opera di una sola mano. Da quel momento, l’epica greca si è trasformata nel simbolo potente di un ordine che nasce in assenza di un piano, un’armonia scaturita dal libero intreccio e dalla contaminazione di innumerevoli voci. I presunti difetti stessi dei poemi quali le incoerenze, le sovrapposizioni, sono, in realtà, i loro inestimabili pregi. Sono la testimonianza palpabile di una vitalità creativa che nessuna regia, per quanto dotta, avrebbe mai potuto costruire a tavolino.
Questo paradigma risuona oggi con una forza sorprendente, ponendosi in aperta opposizione alla crescente tendenza alla pianificazione culturale. Assistiamo a una nuova stagione di burocrazie che tentano di uniformare l’immaginazione: opere riscritte per adeguarle al linguaggio corrente, autori esclusi perché non conformi all’ideologia dominante, programmi educativi piegati a una visione “corretta”. Come i tiranni ateniesi che, si narra, ordinarono i poemi, così gli apparati culturali moderni cercano di sostituire la ricchezza della pluralità con la rassicurante omologazione. Eppure, la lezione di Omero è inequivocabile: la vera arte fiorisce nel disordine creativo, nella libertà delle menti che si confrontano e si contraddicono. È il frutto di un’evoluzione spontanea, la medesima che sostiene le società autenticamente libere e le economie aperte. Nessun pianificatore, per quanto illuminato, potrebbe generare la ricchezza di significati che l’epica ha prodotto nel tempo.
Dagli aedi agli algoritmi: la nuova sfida dell’intelligenza artificiale
La questione omerica trova oggi un parallelo inatteso e inquietante nell’ascesa dell’Intelligenza artificiale. Gli algoritmi generativi, non diversamente dagli antichi aedi, raccolgono, combinano e rielaborano materiali preesistenti, tessendo trame verbali e visive. Tuttavia, se la tradizione epica era il risultato della libertà e della memoria umana, l’IA rischia di divenire una nuova, sottile forma di uniformità. Certo, può apparire come una voce collettiva ma, pur generando, finisce per ripetere in modo eccellente ciò che già esiste, senza il coraggio di una vera innovazione. La differenza è dunque morale prima che tecnica: la creatività umana è intrinsecamente legata all’individualità, al rischio e al giudizio personale, elementi che nessuna macchina può sostituire. Il dubbio di Wolf sull’autore unico anticipa le nostre domande digitali: può esserci arte senza individuo?
La risposta, per chi crede nel sistema di principi della libertà, è netta: no. L’arte, come il libero mercato, sopravvive e prospera solo se l’individuo è libero di creare e di difendere il frutto della propria mente. La proprietà intellettuale non è un privilegio da disprezzare, ma una vera e propria difesa della libertà creativa. Senza di essa, la cultura si riduce a mera amministrazione. Nella Grecia arcaica, ogni aedo era libero di modificare o aggiungere versi; non esisteva un “ufficio poetico” deputato a stabilire la versione corretta. Oggi, al contrario, viviamo l’epoca della revisione ideologica, dove la cultura centralizzata sterilizza la lingua, impoverisce la complessità e attenta alla memoria.
Anche l’educazione, troppo spesso, smarrisce questa fondamentale lezione, degenerando in un esercizio di conformismo in cui la libertà interpretativa è sacrificata sull’altare del moralismo. La civiltà nasce dal dissenso, non dall’uniformità. Proprio come i poemi omerici sono vivi grazie ai loro “pugnantia” (le contraddizioni che li animano), così una società libera si regge sulle differenze, non sull’omologazione.
Omero contro l’apparato: l’eterna battaglia della libertà
Rileggere la questione omerica oggi è, dunque, un atto di difesa dell’autonomia individuale contro la pretesa di un potere, visibile o algoritmico, che aspira a riscrivere ogni cosa: dalla storia ai libri di scuola, dal linguaggio alle emozioni.
Omero (o gli Omeri), ci ricordano che la civiltà non è mai nata da un decreto, ma dall’incontro irripetibile di voci indipendenti, come in un fertile mercato di idee in cui ogni contributo, anche il più piccolo, può rivelarsi indispensabile. L’ordine più fecondo è quello che nessuno ha mai osato imporre. Se Achille si ribella al potere che non gli riconosce il merito, Odisseo trionfa grazie alla sua intelligenza individuale: in entrambi i casi, la libertà personale è la vera virtù, perché il valore si manifesta solo dove la scelta è libera, mai dove la legge comanda.
In conclusione, in un tempo nel quale l’apparato culturale cerca di dettare la fantasia e le intelligenze artificiali ridefiniscono l’autorialità, la questione omerica si erge come un ammonimento inatteso: la cultura è libera o non è.
Ogni sforzo per amministrarla la condanna alla sterilità. Le contraddizioni dell’epica sono la prova lampante che la libertà genera ordine mentre, le uniformità moderne, dimostrano che l’ordine imposto produce solo vuoto. Omero non è un problema del passato; egli rappresenta la vittoria perenne dell’immaginazione contro la pianificazione, della parola contro l’apparato, dell’individuo contro la moltitudine addestrata. L’epica della libertà non è un ricordo sbiadito, ma la sfida più urgente del nostro presente.