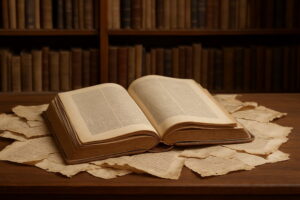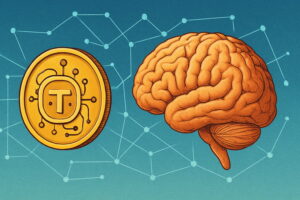L’epoca transumana in cui siamo immersi non è soltanto una singolare congiuntura tecnologica, ma un crocevia di sensi e di destini: l’avanzata inarrestabile dell’intelligenza artificiale, le manipolazioni genetiche e le realtà virtuali non si limitano a cambiare strumenti e ambienti, ma rimodellano l’essenza stessa dell’umano. In questa rivoluzione a ritmi vertiginosi si percepisce un vuoto spirituale, un’erosione delle radici culturali e religiose che da sempre hanno dato forma all’agire e al pensiero. Assistiamo così a un paradosso: da una parte, celebriamo la potenza illimitata di algoritmi e tecniche; dall’altra, rinunciamo al senso del limite, ossatura invisibile che connota ogni autentica esperienza di libertà.
Dal sapere come potere alla responsabilità del sapere
In questo contesto, invocare un generico “credo nella scienza” è diventato un gesto di fede privo di riflessione critica, un rito sostitutivo, un gesto fonetico apotropaico che scambia la ricerca di verità con l’adorazione di un progresso cieco. Francesco Bacone aveva intuito l’alchimia tra sapere e potere e Thomas Hobbes ne aveva distillato l’espressione più esplicita: “il sapere è potere”.
Eppure quel potere, quando ispirato da un sapere raro e consapevole, rivela la propria fragilità e si disegna piuttosto come una manciata di responsabilità. Senza quel retto discernimento, ogni conquista diviene strumento di dominio, mentre la volontà di potenza dilaga senza freni, pronta a varcare la soglia dell’etica e a trasformarsi in imponenza distruttiva.
È perciò indispensabile riscoprire la saggezza del limite, inteso non come negazione della possibilità, bensì quale orizzonte che plasma il desiderio e custodisce il senso del confine. Il “so di non sapere” di Socrate trova un’irrinunciabile corrispondenza contemporanea nel “so di non potere tutto”: una confessione di umiltà culturale e un principio etico che impedisce alla tecnica di fagocitare l’essere umano. Il limite, lungi dal tradursi in una rinuncia, diventa invece la cifra in cui si manifesta la libertà autentica, poiché delimita ciò che conta e circoscrive l’arbitrio dell’arroganza.
Il dislivello prometeico e la crisi dell’uomo tecnologico
Già negli anni cinquanta Gunther Anders parlava del “dislivello prometeico”: l’abisso che si apre tra la rapidità con cui si sviluppano le tecniche e la lentezza con cui le comprendiamo, le governamo e le integriamo nella nostra vita inertiore. In quella forbice si insinua il nichilismo tecnologico, una forma di disperazione che nega ogni possibilità di argine, trasformando l’uomo in apparato obsoleto. A questa tragedia epocale si contrappone l’appello di duecento scienziati – premi Nobel, filosofi, responsabili istituzionali – che invocano la necessità di porre freni allo sviluppo incontrollato dell’intelligenza artificiale: non per bandire l’innovazione, bensì per restituirle orientamento etico e per preservare la vita umana da un’eccessiva mercificazione.
Il respiro antico dei detti inscritti sul tempio di Apollo a Delfi – “Nulla di troppo” accanto a “Conosci te stesso” – conserva un potere rinnovato: ci ammonisce a rifuggire l’ebbrezza senza limiti, a evitare che il consumo, la velocità e l’accumulo divorino il nostro stesso desiderio di senso. Recuperare dunque quella sapienza significa opporsi al dogma dell’onnivoro “sempre di più”, riconoscere che ogni espansione tecnica necessita di un contrappeso spirituale e che la variabile umana non può essere compressa in un dato statistico o in un ciclo algoritmico.
Il sogno inverso di Spielberg: la macchina che desidera l’umano
Il cinema di Steven Spielberg, nel capolavoro Intelligenza Artificiale, rivela un sogno inverso: non è più l’uomo a inseguire la macchina in cerca di risposte, ma il robot-bambino a cercare nell’umano l’abbraccio materno e la luce del divino. Questa girandola di ruoli riflette la nostalgia di autenticità che la tecnica non può saziare: il robot desidera diventare umano, anela alla fiaba, al mito, al gesto sacrale. È un indizio potente, quasi profetico che suggerisce come la macchina stessa possa divenire maestra di limiti, stimolando in noi il risveglio di una coscienza troppo a lungo addormentata.
Solo riscoprendo il dialogo tra scienza e coscienza potremo trasformare l’era transumana in un’opportunità di rinascita dello spirito originario. La ricerca autentica non si riduce all’efficienza degli strumenti, ma si fonda sulla commisurazione attenta di mezzi e fini, sulla valutazione critica delle conseguenze e sulla capacità di sospendere l’ardore del potere quando esso contrasta con il bene comune. In questo compito, il limite non costituisce un retaggio superato, bensì il cuore pulsante di un’etica che dialoga con la tecnica, ne orienta lo sviluppo e protegge il sacro spazio della persona.
Il limite come alleato, non come catena
Che l’uomo sappia dunque riprendere in mano il timone di un destino comune, riconoscendo nel confine non un peso, ma un alleato: il solo antidoto alla voracità prometeica e il più autentico elogio del limite, quello capace di far rifiorire la coscienza tra le macerie di un progresso senza fisionomia e senza volto.
Ecco allora che, guardando con attenzione il film sopra citato, siamo di fronte ad un moderno Pinocchio che aspira ardentemente all’integrità umana, sognando di ritrovare l’abbraccio della madre, ossia un essere artificiale che manifesta una profonda nostalgia per il divino e l’autentico.
Forse, in questo rovesciamento cosmico, sarà proprio l’Intelligenza Artificiale a doverci insegnare la nostalgia dell’uomo, della madre, della fiaba e del divino, risvegliando in noi la coscienza ormai perduta del limite?
Si apre un grande spazio di riflessione. Dobbiamo augurarci che ci sia.