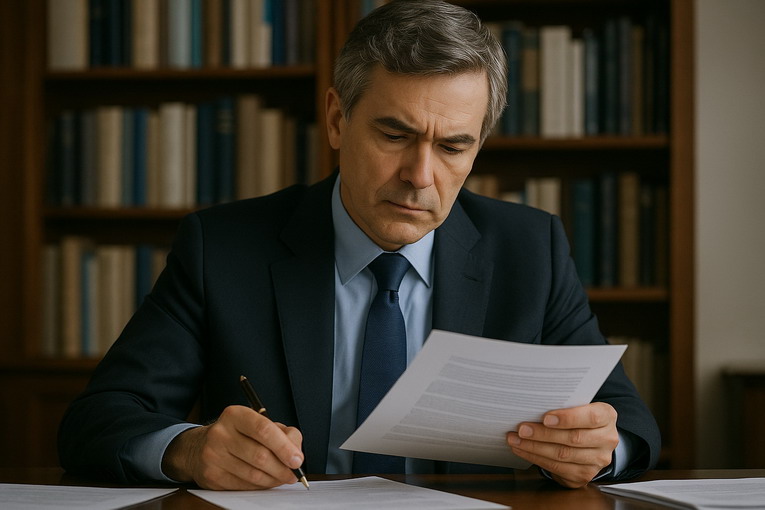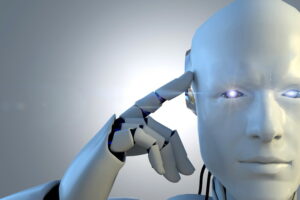Il panorama giuridico italiano è prossimo a una svolta epocale, incarnata dalla legge di riforma della giustizia approvata dal Parlamento, la quale sarà sottoposta al giudizio popolare mediante referendum confermativo nella primavera del 2026, in ottemperanza all’articolo 138 della Costituzione. Questa iniziativa legislativa non è un evento isolato, ma piuttosto la conclusione di uno sviluppo lungo e meditato, avviato nel 1988 e proseguito con tappe fondamentali nel 1999 e nel 2022
Le origini: la riforma Vassalli del 1988
Tutto ha origine in quel del 1988, quando, sulla scorta dei lavori di una commissione di studio presieduta dal Professor Pisapia, il ministro della Giustizia socialista Giuliano Vassalli, insigne studioso di procedura penale, promosse e fece approvare una radicale metamorfosi della struttura del processo penale.
La trasformazione dal modello inquisitorio a quello accusatorio ha cristallizzato il processo penale attorno a tre figure distinte: l’accusa, sostenuta dai pubblici ministeri; la difesa, curata dall’avvocato dell’accusato; e il giudice, posto in una necessaria posizione di imparzialità tra le parti contendenti.
Vassalli stesso sosteneva che la separazione delle carriere rappresentasse la naturale e imprescindibile conseguenza della distinzione funzionale appena istituita.
La consacrazione costituzionale del 1999
Questo principio di terzietà e parità ha trovato in seguti la sua solida consacrazione costituzionale nel 1999, con la modifica dell’articolo 111 della Costituzione che oggi statuisce – e lo perentoriamente – che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».
L’iter evolutivo ha conosciuto un ulteriore e significativo passo nel 2022, quando l’allora Ministro della giustizia Marta Cartabia, già presidente della Corte Costituzionale, propose al Parlamento una limitazione dei passaggi tra le carriere di pubblici ministeri e giudici, segnando un inizio della separazione.
Il disegno di legge costituzionale giunto ora a compimento, approvato con le due successive deliberazioni a intervallo non inferiore a tre mesi e a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione, come richiesto dalla Costituzione, attua il pieno riconoscimento dell’esistenza di due funzioni radicalmente diverse: quella investigativa e quella giudicante.
Tali funzioni richiedono specializzazioni interamente dissimili. La decisione che il corpo elettorale sarà chiamato a ratificare con il referendum confermativo è, per molti versi, un atto dovuto, lungamente maturato nel pensiero giuridico italiano, volto a garantire ai cittadini la massima assicurazione di imparzialità del magistrato nell’ambito del rapporto trilaterale tra accusa, difesa e giudizio.
Un principio di logica e garanzia democratica
L’esigenza di separazione si fonda su un principio di logica funzionale elementare: se vengono individuate due funzioni distinte, quella di accusatore e quella di giudice, è imperativo che queste siano attribuite a organi diversi e tra loro separati, vale a dire i magistrati dell’accusa e i magistrati giudicanti. Il Prof. Cassese fa addirittura questo paragone: assimilando il concetto al corpo umano, risulterebbe illogico adoperare una medesima parte per funzioni antitetiche (come usare le braccia per camminare e le gambe per scrivere); a funzione diversa deve corrispondere organo diverso.
In questo contesto, la riforma non solo si conforma alla Costituzione, ma ne costituisce l’attuazione di un principio già fissato. Inoltre, è previsto che al corpo dei pubblici ministeri, una volta separato da quello dei magistrati giudicanti, siano attribuite le medesime garanzie oggi estese all’intera magistratura.
Il principio del garantismo esige che venga data piena attuazione alla Costituzione, ove le parti operano in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale. Non si può ritenere che chi si difende goda di parità piena nei confronti di un procuratore che appartiene al medesimo corpo del magistrato giudicante: l’autentico e vero garantismo postula un rapporto a tre in cui sia chiaramente definita la differenziazione dei ruoli e degli organici.
Infine, occorre accennare alla fase referendaria che si preannuncia complessa, con il rischio di una campagna pervasa da toni politicizzati e inappropriati.
Il significato profondo della democrazia diretta
La politicizzazione di una modifica costituzionale può comportare una distorsione della democrazia diretta: il nostro ordinamento si fonda sulla democrazia rappresentativa che si esprime nell’elezione dei parlamentari e sulla democrazia deliberativa, realizzata attraverso il referendum. Se al referendum si attribuisce un significato eccedente, configurandolo come un voto di sostegno o di censura nei confronti del governo in carica, se ne tradisce il senso profondo, conferendo al risultato una legittimazione propria dell’elezione.
Qualora i partiti di maggioranza si schierassero per l’approvazione, una vittoria referendaria potrebbe essere letta come un popolare avallo all’esecutivo attuale. Analogamente, uno schieramento dell’Associazione magistrati a favore del no, in caso di esito negativo, potrebbe essere interpretato come una delegittimazione popolare dell’intera magistratura.
Ci sentiamo di poter dire che, se ciò avvenisse, si rischierebbe di convertire la democrazia diretta in una nuova specie di democrazia rappresentativa, tradendo la domanda costituzionalmente posta all’elettore, poiché ciò che è sottoposto al vaglio referendario è un atto esclusivo del Parlamento e non del Governo.
Da ultimo, da cittadino, auspicherei, per chiudere il cerchio, una riforma che riguardi anche la parte civilistica che, in questa riforma, non viene toccata.
Abbiamo atteso oltre trent’anni la prima. Ce ne vorranno altrettanti per la seconda?