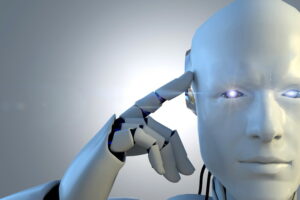Singolare è la contingenza che vede le recenti osservazioni di Mario Draghi sulla caducità delle premesse del Green Deal manifestarsi nel decennale del Dieselgate, un evento di portata catalizzatrice che dal 2019 ha indirizzato l’Unione Europea verso la transizione ecologica e la mobilità elettrica. Il 18 settembre 2015, l’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (EPA) notificò a Volkswagen AG, Audi AG e Volkswagen Group of America la violazione del Clean Air Act, rivelando come i veicoli diesel del Gruppo tedesco fossero equipaggiati con un software atto a eludere i test sulle emissioni.
Questo dispositivo, eufemisticamente denominato defeat device, era progettato per riconoscere le condizioni di laboratorio e attivare la massima efficienza dei sistemi di abbattimento degli ossidi di azoto. Sull’arteria stradale, tuttavia, i filtri venivano disattivati per ottimizzare le prestazioni, creando una dicotomia paradossale: la vettura si presentava immacolata in laboratorio, ma altamente inquinante in circolazione. Lo scandalo culminò nel crollo del 20% delle azioni Volkswagen il 21 settembre 2015 e nelle dimissioni dell’allora amministratore delegato Martin Winterkorn. Il Dipartimento di Giustizia statunitense lo qualificò come uno dei crimini aziendali più sfacciati della storia, evidenziando le dichiarazioni mendaci alle autorità ambientali e la deliberata elusione dei limiti di emissione.
La reazione degli Stati Uniti a quella che percepivano come un’incalzante supremazia del diesel “pulito” tedesco si concretizzò in un presidio regolatorio anziché tariffario. Il costo complessivo per Volkswagen eccedette i trentadue miliardi di euro, tra sanzioni, accordi transattivi e compensazioni. La lesione reputazionale indelebile imposta alla Germania costrinse Volkswagen a una profonda metamorfosi, accelerando l’ingresso nel settore elettrico, un passo strategicamente ancorato a una partnership pluridecennale con le case automobilistiche cinesi. Questa collaborazione, risalente al 1983, si inseriva nella visione di espansione industriale di Pechino, con la mobilità elettrica quale fulcro dello sviluppo. Le successive strategie, da Together Strategy a Transform 2025+, testimoniarono l’impegno di Volkswagen verso l’elettrificazione, con obiettivi ambiziosi di modelli a zero emissioni entro il 2025 e poi il 2019.
L’Ipocrisia del Green Deal: una spinta indotta e un trionfo mancato
La transizione verso l’elettrico, di fatto, era già in atto e dettata da necessità industriali tedesche prima dell’adozione del Green Deal europeo. La politica di Bruxelles, sotto la presidenza di Ursula von der Leyen, offrì il sostegno politico invocato dall’industria automobilistica tedesca. Il pacchetto Fit for 55, presentato nel 2021 e trasposto nel Regolamento (UE) 2023/851, sancì l’obbligo di azzeramento delle emissioni di CO₂ per tutte le auto nuove dal 2035, di fatto ratificando la supremazia dell’auto elettrica e proiettando la rottamazione di circa 250 milioni di veicoli.
Emerge qui una chiara manifestazione dell’ipocrisia della UE: un’intera politica continentale, presentata come imperativo ecologico, che forniva in realtà una giustificazione e un supporto normativo a una strategia industriale già avviata e necessaria per la prima economia dell’Unione. Tuttavia, questo trionfo programmatico non si è concretizzato. I costruttori cinesi, detenendo il primato in materie prime e tecnologia delle batterie, hanno rapidamente colmato il divario, superando i concorrenti europei i cui modelli elettrici stentano a conquistare il mercato. Oggi, i marchi cinesi esercitano l’egemonia nel panorama globale dell’auto elettrica, mentre le case europee, in evidente sofferenza, cercano alleanze per contenere danni che appaiono ormai difficilmente recuperabili. Chi denunciò i rischi di questa strategia fu presto tacciato di allarmismo e nessuna scusa è giunta da chi ci ha condotti in questa nuova crisi. Anzi, ora sembrano proporsi anche come artefici della cura.
Il parallelo narrativo: dall’ambiente al nemico esterno, la stessa regia tedesca
La matrice strategica permane inalterata: la Germania detta le regole europee… finché non convengono più. A quel punto, le modifica. Questa dinamica è manifesta nel passaggio dall’austerità imposta ai partner dell’eurozona, con rigidi vincoli di bilancio, a un nuovo paradigma in cui tali regole possono essere derogate, purché per finalità belliche. Il mantra è mutato e la “sovranità strategica europea”, un concetto tanto vago quanto strumentale, viene invocata.
Strumentale a cosa? A rilanciare l’industria militare e metallurgica tedesca, quella stessa che oggi stenta sotto il peso della deindustrializzazione accelerata dalla precedente transizione ecologica. Non si tratta di difesa comune, bensì di una nuova forma di politica industriale continentale, con Berlino quale primo beneficiario.
Siamo dinanzi a una crisi interna con una soluzione bellica. L’economia tedesca, storicamente dominata dall’export manifatturiero e dalla chimica, sta perdendo vigore. I giganti energetici post- nucleari faticano, le acciaierie soffrono la concorrenza globale e la domanda interna è stagnante. Ciò che resta è la difesa, finanziata con fondi straordinari, esterni al bilancio ordinario, con deroghe confezionate su misura.
Il piano è lucido: rilanciare l’industria strategica nazionale attraverso la produzione di armi, blindature e componentistica per sistemi NATO. La legittimazione di questa virata è fornita da una narrazione emergenziale: la minaccia russa, il conflitto in Ucraina, l’instabilità globale. Il nemico viene strumentalizzato con sagace opportunismo politico per giustificare spese fino a ieri impensabili. Qui risiede il nocciolo della questione dell’utilizzo della stessa narrazione: un pericolo esterno, sia esso ambientale o geopolitico, viene impiegato per legittimare e orientare politiche economiche e industriali che primariamente giovano agli interessi nazionali tedeschi, sotto l’egida di un’Unione Europea acquiescente.
L’Italia, benché tradizionalmente subalterna nei grandi equilibri dell’eurozona, si allinea, non solo per docilità, ma anche per i potenziali ritorni economici. Il comparto industriale militare italiano può beneficiare della corsa agli armamenti, pur ricoprendo un ruolo di fornitore intermedio e partner industriale, piuttosto che di attore dominante. Tale partecipazione, seppur non marginale, comporterà vantaggi circoscritti a imprese strategiche, capitali privati e distretti industriali legati alla difesa, a scapito del welfare, delle infrastrutture civili e del lavoro stabile. Il rischio è quello di un nuovo ciclo di crescita artefatto dal comparto bellico.
Il riarmo europeo, nella sua configurazione attuale, non è affatto autonomo. L’Unione si proclama “sovrana”, ma è intrinsecamente integrata nel paradigma industriale e strategico statunitense. La maggior parte dei sistemi d’arma – missili, radar, software, tecnologie dual use – rimane saldamente in mano americana. Mentre le aziende europee si affannano per ottenere una fetta del budget, giganti come Lockheed Martin, Raytheon e General Dynamics si assicurano i contratti più lucrosi. L’Europa spende, l’America incassa. E, come sempre, gli armamenti prodotti dovranno trovare una “collocazione”: teatri di crisi, tensioni pilotate, guerre per procura, come già si è osservato in Africa, nel Mar Rosso, nel Mediterraneo allargato.
Un’Europa militarizzata al costo del welfare
Il rischio non è meramente economico, ma etico. Un’Europa che si reindustrializza sulle armi è un’Europa che sarà, prima o poi, chiamata a usarle. Contro qualcuno. Da qualche parte. La dicotomia è chiara: armi sì, welfare no. L’Europa, oggi, si riarma per rilanciare la propria industria e superare una crisi che essa stessa ha contribuito a generare: dapprima con l’austerità, ora con la militarizzazione dell’economia. Coloro che imponevano i vincoli, ora li abbattono; coloro che li subivano, ora si adeguano. E nel frattempo, i popoli pagano: in tagli, in disuguaglianze, in servizi che si svuotano.
Apparentemente, si tratta di una strategia di sicurezza. In realtà, è una strategia di sopravvivenza del modello europeo che ridisegna la propria fisionomia con le insegne belliche. Tuttavia, una questione ineludibile e urgente permane: può davvero esistere una pace edificata sulle armi? O stiamo semplicemente predisponendo, pezzo dopo pezzo, il prossimo conflitto che giustificherà questo imponente riarmo?