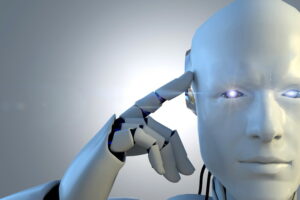Vi è qualcosa di profondamente paradossale nell’idea, recentemente rilanciata da autorevoli penne del giornalismo italiano, di multare chi non esercita il diritto di voto. Il direttore de La Stampa, Andrea Malaguti, l’ha formulata con la franchezza che gli è propria: «Penso che dovremmo votare tutti. Obbligatoriamente. Per legge. C’è un’elezione? Si va. Per forza. Chi sta a casa paga». Una provocazione, l’ha definita lui stesso. Ma le provocazioni migliori sono quelle che, nel loro eccesso, rivelano un equivoco più profondo. E l’equivoco, in questo caso, riguarda la natura stessa del rapporto tra diritto e dovere.
Il voto tra diritto e dovere: cosa dice davvero la Costituzione
La nostra Costituzione, all’articolo 48, definisce il voto un «dovere civico». Parole scelte con cura certosina dai Costituenti, che rigettarono sia l’obbligatorietà pura sia la mera facoltà. Il dovere civico è un impegno morale, non una prescrizione sanzionabile. È l’appello alla coscienza del cittadino, non il braccio dell’esattore. Una distinzione che potrebbe apparire bizantina, se non fosse che su di essa si regge l’intera architettura delle libertà democratiche.
Consideriamo infatti cosa accade quando un cittadino commette un reato grave. L’articolo 28 del codice penale prevede, tra le pene accessorie, l’interdizione dai pubblici uffici. E cosa comporta tale interdizione? In primo luogo, la perdita del diritto di voto. Un diritto che viene revocato come conseguenza della violazione dei doveri verso la comunità. Ora, si rifletta: si può forse revocare un dovere? I doveri si impongono o si sollevano; i diritti si concedono o si tolgono. Se il voto fosse propriamente un dovere, non potrebbe essere sottratto come sanzione. Il fatto stesso che possa essere perduto dimostra che è, nella sua essenza, un diritto.
Un diritto che nasce dai doveri: il patto originario della cittadinanza
Ma questo diritto non sorge dal nulla. Non è un dono gratuito che la società elargisce ai suoi membri senza chiedere nulla in cambio. È, piuttosto, il frutto di un patto tacito che lega il cittadino alla sua comunità attraverso l’adempimento di obblighi reciproci. Per comprendere questa dinamica, occorre risalire alle radici stesse del pensiero politico occidentale.
Civis Romanus sum. Questa formula, che ancora oggi risuona nelle aule dei tribunali e nelle pagine dei trattati, non designava un privilegio ereditario ma uno status guadagnato e mantenuto attraverso l’adempimento di precise obbligazioni. Il cittadino romano godeva dello ius suffragii — il diritto di voto nelle assemblee — e dello ius honorum — il diritto di essere eletto alle magistrature. Ma questi diritti erano inscindibili dai munera: il servizio militare nelle legioni, il pagamento dei tributi, la partecipazione attiva alla vita della res publica.
Il termine stesso munus — da cui deriva «municipio» — indica nel Digesto «l’ufficio, il dovere o l’obbligo imposto dalla legge, dalla consuetudine o dall’ordine di chiunque sia in una posizione di comando». I giuristi medievali, commentando questi testi, giunsero a definire il civis come «un insieme di doveri più che un insieme di diritti». La cittadinanza non era un’etichetta anagrafica ma una condizione conquistata e confermata quotidianamente attraverso l’esercizio delle responsabilità verso la comunità.
Dal civis romano al pensiero medievale: la cittadinanza come obbligazione
È Cicerone a sistematizzare questa visione nel De Officiis, l’ultimo dei suoi trattati, scritto nell’autunno del 44 a.C. mentre la Repubblica agonizzava sotto i colpi dei triumviri. Rivolgendosi al figlio Marco, il vecchio console tracciava una mappa delle obbligazioni morali che legano l’individuo alla società:
«Non c’è momento della vita — sia negli affari pubblici che nei privati, sia nei forensi che nei domestici — non c’è momento che si sottragga al dovere. Così come nell’adempimento del dovere consiste tutta l’onestà della vita, nell’inosservanza di esso risiede tutta la disonestà.»
Per Cicerone esistono due forme di ingiustizia: quella attiva, che si realizza in un’aggressione aperta ai diritti altrui, e quella passiva, per omissione, «che consiste nel trascurare i propri doveri verso gli altri e verso la società nel suo complesso». L’astensionismo, in questa prospettiva, non sarebbe tanto l’esercizio di un diritto quanto una forma di ingiustizia passiva — non perché il cittadino debba essere costretto a votare, ma perché, nel patto di cittadinanza, egli si è assunto l’onere morale di partecipare alle decisioni collettive.
Cicerone e l’ingiustizia per omissione: perché l’astensione non è indifferenza
Ma Cicerone non avrebbe mai immaginato di sanzionare questa omissione con una multa. Perché comprendeva che la coercizione svuota l’atto morale del suo significato. Un voto estorto sotto minaccia di sanzione non è più espressione di cittadinanza ma adempimento burocratico.
Diciotto secoli dopo, nell’austera Königsberg, Immanuel Kant avrebbe portato questa intuizione alle sue conseguenze ultime. L’imperativo categorico — «agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere come principio di una legislazione universale» — fonda la morale non sull’obbedienza a un’autorità esterna ma sull’autonomia della ragione. Il dovere, per Kant, non è una catena che vincola ma il fondamento stesso della libertà.
La seconda formulazione dell’imperativo — «agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo» — è stata riconosciuta come la radice filosofica della moderna idea di diritti umani. Ma si noti la sequenza logica: è dal riconoscimento del dovere verso l’umanità che scaturisce il diritto di ogni individuo ad essere trattato con dignità. Il dovere precede e fonda il diritto. Non viceversa.
Perché il dovere non può essere imposto: la lezione di Kant sulla libertà
Qui sta il nodo che la proposta Malaguti, pur nella sua schiettezza provocatoria, non riesce a sciogliere. Non si può imporre con la multa ciò che deve nascere dalla coscienza. Sarebbe come pretendere di far crescere un albero tirandolo per i rami. L’astensionismo non è una malattia che si cura con l’antibiotico della sanzione; è il sintomo di un patto sociale che si è logorato, di una fiducia che si è incrinata, di un senso del dovere civico che non viene più trasmesso.
Lo dimostra l’esperimento cileno, spesso citato dai fautori del voto obbligatorio. Nel 2022 il Cile ha reintrodotto la sanzione per chi non vota: l’affluenza è balzata dal 47% all’85%. Un successo? Solo in apparenza. Perché le schede nulle sono passate dall’1,2% al 17%. I cittadini sono andati alle urne per evitare la multa, non per esercitare una scelta. Hanno adempiuto la forma svuotandola di sostanza. Come osservò un commentatore: «Abbiamo ottenuto più votanti ma non più cittadini».
C’è una generazione — ma forse sono già due o tre — che ha interiorizzato l’idea che i diritti siano gratuiti, che si possano esigere senza corrispettivo, che siano dovuti per il solo fatto di esistere. È l’illusione del massimo risultato con il minimo sforzo, applicata alla sfera politica. Ma i Romani sapevano che il civis senza munera è una contraddizione in termini. Cicerone insegnava che chi trascura i doveri verso la comunità commette un’ingiustizia, anche se passiva. Kant comprese che solo attraverso l’autonomia morale — il dovere che ci si impone da sé — si accede alla vera libertà.
Il cortocircuito contemporaneo: diritti senza doveri
La risposta all’astensionismo non è la multa. È la ricostruzione paziente di quella catena di trasmissione — dalla famiglia alla scuola, dalla comunità alle istituzioni — che dovrebbe insegnare a ogni cittadino che i diritti sono il frutto dei doveri adempiuti, non un regalo che si trova sotto l’albero di Natale. Che votare non è una seccatura burocratica ma l’esercizio di una responsabilità conquistata da generazioni di uomini che per quel diritto hanno lottato e spesso sono morti.
Multare chi non vota è un po’ come multare chi non prega. Si può forse imporre la fede con la sanzione? No, e neppure la partecipazione civica. Si può solo coltivarla, giorno dopo giorno, con l’esempio e con l’educazione. Il resto è — per usare le parole di un critico di Malaguti — «la più grezza pedagogia applicata permanentemente a tutti» da chi non ha ancora imparato la lezione fondamentale: che nessuno vuole essere educato da chi pretende di insegnare a forza.
Cicerone concludeva il De Officiis ricordando al figlio che «le città, senza l’unione degli uomini, non avrebbero potuto essere né edificate né popolate: di lì furono stabilite le leggi e i costumi, l’equa ripartizione dei diritti e dei doveri e una regola sicura di vita». L’ordine delle parole non è casuale: prima vengono i doveri, poi i diritti. Prima viene l’edificazione comune, poi la ripartizione dei benefici. Prima viene il munus, poi lo ius.
È una lezione che duemila anni non hanno scalfito. E che nessuna multa potrà mai sostituire.