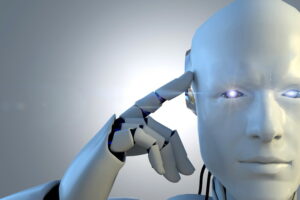Oxford University Press incorona rage bait parola dell’anno. Treccani risponde con fiducia. Non è una coincidenza lessicale. È una frattura simbolica.
Non due vocaboli, ma due archetipi che si fronteggiano, come placche tettoniche sotto la superficie del nostro tempo. Da una parte l’esca algoritmica della rabbia, dall’altra la virtù razionale del patto umano. In mezzo, un’umanità stanca, iperstimolata, sempre più incapace di distinguere tra reazione e pensiero.
Il 2025 non si apre come un nuovo anno qualsiasi.
Si presenta come un bivio antropologico: non tra destra e sinistra, non tra progresso e conservazione, ma tra emozione indotta e coscienza deliberata. E il fatto che questo conflitto emerga dal linguaggio, dal modo in cui nominiamo il mondo, è forse il segnale più inquietante.
Rage Bait: l’ingegneria della rabbia permanente
Il rage bait non è un incidente del digitale. È la sua forma più efficiente.
Contenuti progettati con precisione chirurgica per innescare indignazione: immigrazione, vaccini, identità, sovranismi, élite. Non per informare, ma per provocare una risposta viscerale, breve, replicabile, monetizzabile. Meta, TikTok, X non “ospitano” questa dinamica: la premiano strutturalmente. Gli algoritmi non distinguono tra verità e falsità, ma tra engagement alto e basso. E nulla genera engagement come la rabbia.
Il risultato è una nuova figura antropologica: l’utente come rage farmer.
Coltiva indignazione per visibilità, traffico, micro-potere simbolico. Ogni commento è un grido, ogni condivisione un riflesso condizionato. Non è partecipazione democratica: è estrazione emotiva.
Nel contesto nazionalpopolare italiano — ma non solo — questo meccanismo trova terreno fertile. Le piazze fisiche si svuotano, quelle digitali urlano. Il discorso pubblico si riduce a slogan compressi, meme identitari, nemici caricaturali. Leader politici e imprenditori dell’attenzione imparano presto la lezione: dividere conviene. Non chiarire, non spiegare, non costruire. Dividere.
E attenzione: non è spontaneità. È design.
Dal 2022 le interazioni generate da contenuti polarizzanti sono triplicate. Ma insieme all’engagement cresce qualcosa di meno misurabile e più tossico: la sfiducia sistemica, l’erosione del patto sociale, la traduzione dell’online in conflitto offline. Proteste violente, delegittimazione cronica delle istituzioni, sospetto come postura permanente.
Fiducia: non ingenuità, ma architettura razionale
In questo scenario, la scelta di Treccani — fiducia — suona quasi anacronistica. E proprio per questo è radicale.
La fiducia non è credulità. È un atto razionale di delega. È ciò che rende possibili i mercati, le democrazie, le relazioni complesse. Senza fiducia non esistono contratti, conoscenza condivisa, futuro. Esiste solo difesa preventiva.
Il rage bait, però, vive della sua negazione: una sfiducia iperbolica, paranoica, che trasforma ogni informazione in trappola e ogni interlocutore in potenziale nemico. Le echo chamber non sono solo bolle informative: sono camere di risonanza identitaria, dove il “noi” si frantuma in una miriade di “io armati”.
Ricostruire fiducia non significa tornare a un’innocenza perduta. Significa dotarsi di strumenti: alfabetizzazione mediatica per decodificare gli algoritmi, regolamentazioni come GDPR e DSA per limitare il saccheggio emotivo, un umanesimo tecnologico che restituisca agency all’individuo invece di ridurlo a profilo predittivo.
Eppure la fiducia è faticosa. Richiede tempo, dubbio, sospensione del giudizio. Tutto ciò che il rage bait disprezza. L’adrenalina della rabbia è più semplice, più rapida, più gratificante. E così il patto sociale viene sacrificato sull’altare dell’emozione immediata.
Una trappola che riguarda tutti
Sarebbe comodo fermarsi qui. Attribuire la colpa a un “popolo manipolato”, a un nazionalpopolare rozzo e urlante. Ma sarebbe falso — e intellettualmente disonesto.
Nessuno è immune.
Nemmeno chi si crede alfabetizzato. Nemmeno chi pensa di osservare il sistema dall’alto. Il rage bait non colpisce solo l’ignoranza: colpisce l’ego, il bisogno di sentirsi nel giusto, il piacere sottile della superiorità morale.
È qui che la questione diventa davvero antropologica.
L’assenza di consapevolezza: verso un transumanesimo opaco
La rabbia permanente erode qualcosa di più profondo del dibattito pubblico: erode il logos.
L’uomo viene progressivamente modellato come entità prevedibile, reattiva, profilabile. La rabbia cronica produce brain rot: bias negativi, percezioni distorte, incapacità di visione lunga. Le big tech non si limitano a osservare questi pattern: li raffinano, li usano per anticipare comportamenti, orientare scelte, sperimentare forme embrionali di governance predittiva.
Nel frattempo, senza quasi accorgercene, deleghiamo.
All’intelligenza artificiale affidiamo diagnosi, selezioni, valutazioni. All’algoritmo demandiamo priorità, visibilità, reputazione. L’uomo diventa economicamente superfluo e spiritualmente svuotato, ridotto a flusso di dati commerciabili.
Questo è il volto di un transumanesimo opaco, non dichiarato, non discusso.
E mentre accade, il dibattito pubblico resta intrappolato in meme anti-élite e teorie cospirative da share compulsivo. Come prigionieri della caverna digitale, combattiamo ombre mentre la struttura della realtà viene riscritta alle nostre spalle.
Qui si consuma quella che Hofstadter avrebbe chiamato l’erosione dell’autonomia tra mente e macchina: non una fusione consapevole, ma una deriva silenziosa, in cui il pensiero smette di essere spazio di riflessione e diventa risposta condizionata.
Fine anno, non fine tempo
Questo editoriale non è un proclama. È un avvertimento. Il 2025 non segna la fine di nulla. Ma segna una soglia.
Possiamo continuare a nutrire la macchina con la nostra rabbia, accettando una progressiva infantilizzazione emotiva mascherata da partecipazione. Oppure possiamo reclamare la fatica della fiducia, del discernimento, del pensiero non immediato.
La vera domanda non è se vincerà la rabbia o la fiducia.
La vera domanda è quanta parte di noi saremo disposti a delegare prima di accorgerci che non stiamo più scegliendo.
E a fine anno, quando tutto rallenta per un istante, forse vale la pena fermarsi qui. Non per rispondere. Ma per ascoltare il silenzio che resta quando l’algoritmo smette di urlare.