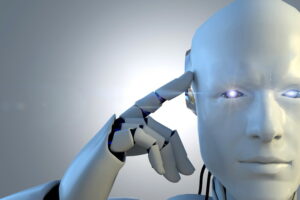La contemporaneità è caratterizzata da una duplice tensione inerente al fenomeno della violenza: da un lato, l’emersione di una marcata asimmetria nell’uso e nell’apologia della forza in seno alle dinamiche politiche interne; dall’altro, la messa in discussione empirica del celebre paradigma storiografico che postulava il declino secolare della violenza a livello globale.
Il panorama italiano
In Italia, il panorama politico degli ultimi anni rivela una singolare asimmetria nella manifestazione e nell’esaltazione della coercizione. Sebbene in passato l’estremismo politico — tanto di sinistra (come le Brigate Rosse) quanto di destra (come i NAR) — avesse teorizzato e messo in pratica il ricorso alla violenza, oggi si osserva che tale prassi è quasi esclusivamente appannaggio di gruppi e individui riconducibili all’area progressista o genericamente anti-fascista.
Tale disuguaglianza comportamentale si traduce in una normalizzazione di atti simbolici e materiali di coercizione: si pensi all’esposizione pubblica di immagini di leader politici di destra (quale ad esempio Giorgia Meloni) a testa in giù; all’impedimento fisico di dibattiti, presentazioni librarie o cicli di lezioni a causa della presenza di ebrei o esponenti politici conservatori; o ancora, all’organizzazione di contro-cortei da parte di antagonisti e centri sociali mirati a sabotare la pacifica manifestazione di piazze avverse. Tale condotta coercitiva è talvolta accompagnata da slogan inquietanti, quali il vecchio adagio “uccidere un fascista non è reato”, preceduto da raccapriccianti variazioni come “il maresciallo Tito ce l’ha insegnato…” (in un ambiguo riferimento alle foibe?) o “la nonna partigiana ce l’ha insegnato”.
Sebbene l’obiezione riguardante episodi violenti attribuibili anche alla destra (come l’assalto di Forza Nuova alla CGIL) sia legittima, essa non coglie il punto nevralgico della questione, poiché è la frequenza e, soprattutto, l’ampiezza del sostegno a tali azioni che risulta incomparabilmente superiore in seno alla sinistra. Ciò che amplifica la preoccupazione è la reazione che tali episodi suscitino: comprensione, prudente silenzio, minimizzazione, talora persino compiacimento in una parte dell’establishment progressista.
Asimmetria morale e psicologica
Dietro questa marcata asimmetria comportamentale, si cela una asimmetria morale e psicologica più profonda che potremmo chiamare gli “orrori del bene”. La differenza cruciale risiede nella percezione della validità dei propri principi. Il militantemoderato- conservatore è generalmente consapevole della parzialità del suo punto di vista, mentre quello progressista è animato dalla ferma convinzione della superiorità e della giustezza intrinseca delle proprie istanze. Queste ultime vengono percepite non come opinioni politiche, bensì come valori universali e non negoziabili. In virtù di questa auto-percezione etica, tali valori sono ritenuti degni di essere imposti alla collettività con le buone o con le cattive. Tale atteggiamento, tipico di tutti i fondamentalismi, conduce all’attrazione per il mezzo di coercizione fondamentale sempre disponibile a chiunque: l’esercizio della violenza.
Il dibattito sull’andamento della violenza e in particolare sui tassi di omicidio, è da sempre un terreno altamente infiammabile. Per anni, la tesi del declino secolare della violenza è stata dominante, sostenuta da autorevoli lavori scientifici, come quelli del criminologo Manuel Eisner sul crollo degli omicidi in Europa dall’Alto Medioevo e portata alla ribalta mediatico con l’opera del 2011 dello psicologo americano Steven Pinker, “Il declino della violenza” che ambiva a spiegare “perché quella che stiamo vivendo è probabilmente l’epoca più pacifica della storia”. Il fondamento di questa teoria risiede nell’idea che forze storiche quali la democratizzazione, la modernizzazione, la civilizzazione e l’invecchiamento demografico, siano motori ineluttabili che sospingono verso il basso il tasso di omicidio.
Tuttavia, il recente rilascio dei dati statistici delle Nazioni Unite relativi al 2023 offre un’opportunità di analisi cruciale, permettendo confronti “covid-free” tra l’ultimo anno di dati (2023) e l’ultimo anno pre-pandemico (2019). I risultati di questa comparazione mettono in discussione l’universalità del declino.
Il quadriennio 2019-2023
Nelle società avanzate (occidentali o occidentalizzate), si osserva una preoccupante inversione di rotta. Nel quadriennio 2019-2023, si è registrato un aumento sensibile delle uccisioni sia di uomini sia di donne, una tendenza assente nel quadriennio precedente. L’aumento degli omicidi coinvolge sfortunatamente 3 società avanzate su 4. Negli Stati Uniti, in particolare, l’incremento è stato marcato, con le uccisioni di maschi aumentate del 18% e quelle di donne del 21.5% nel periodo 2019-2023, consolidando una crescita già in atto. Anche in Italia si registra un cambiamento di regime tra i due quadrienni, con le uccisioni di uomini e donne in lieve aumento (a fronte della forte diminuzione precedente).
Anche nelle società meno sviluppate, il processo di rapida riduzione della violenza osservato nel 2015-2019 si è interrotto nel quadriennio successivo.
Queste evidenze suggeriscono che l’aggressività e il ricorso alla violenza si stanno nuovamente insinuando nelle “civilissime democrazie”.
Di conseguenza, la conclusione si impone con chiarezza: forse non viviamo affatto nell’ epoca più pacifica della storia”. Non solo per gli eccidi russi-ucraini, Gaza, Sudan, Myanmar, ma perché – da qualche anno – aggressività e ricorso alla violenza si stanno facendo strada anche nelle nostre civilissime democrazie.