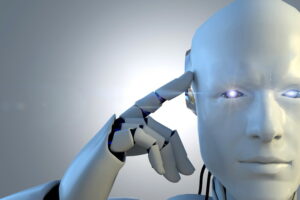Si aggira tra di noi un mostro, un Leviatano che non brandisce la spada come quello di Hobbes, ma la cartella esattoriale. È il potere fiscale degli Stati europei, tornato a crescere insieme alla convinzione che più tasse significhino più giustizia, più redistribuzione, più civiltà. È però un’illusione che i numeri smentiscono con crudezza: secondo le ultime rilevazioni di Eurostat, nel 2024 la pressione fiscale media dell’Unione europea ha toccato il 40,4 per cento del Pil, mentre in Italia ha superato il 42,6 per cento. Numeri che, per molti governi, rappresentano un successo, mentre in realtà, misurano l’opposto: la progressiva sottrazione di risorse e responsabilità alla società civile. Perché, quando il fisco cresce, la libertà arretra e con essa la cooperazione sociale che da volontaria diventa coercitiva.
Dalla giustizia fiscale al potere politico
Questi dati non raccontano solo un fenomeno economico, ma una trasformazione culturale: l’idea che lo Stato debba sostituirsi al cittadino nella gestione della ricchezza, decidendo chi merita e chi deve finanziare, chi aiutare e chi colpire. È così che il prelievo diventa una nuova forma di potere, una leva politica che misura la fiducia non nella libertà, ma nell’obbedienza.
Come appare evidente, ed è del resto facilmente riscontrabile, l’aumento del prelievo non dipende solo da bisogni contingenti quanto il frutto di una mentalità consolidata che considera la tassazione come strumento di giustizia e la redistribuzione come dovere morale.
Da questa convinzione discende una visione rovesciata del rapporto tra Stato e cittadino: non più il potere pubblico al servizio dell’individuo, ma, al contrario, è quest’ultimo al servizio dello Stato. È così che l’imposta, da mezzo per finanziare funzioni comuni, diventa fine politico, misura dell’equità e strumento di consenso.
L’illusione della redistribuzione
Senonché, la storia dimostra l’esatto opposto: quando il potere pubblico si espande e il fisco cresce oltre misura, non si redistribuisce affatto la ricchezza, si redistribuisce la dipendenza. La pressione fiscale è, in fondo, la misura della fiducia che lo Stato ripone nei suoi cittadini: più li tassa, meno li considera capaci di scegliere e di agire per sé. L’idea di fondo è sempre la stessa ˗ che l’individuo debba essere guidato ˗ e da essa deriva la crescita continua dell’intervento pubblico, delle norme, dei vincoli, delle pretese.
Ed è proprio questa mentalità paternalistica che si riflette nei numeri diffusi dal medesimo istituto europeo di statistica. Questo segnala infatti che, nel 2024, il gettito complessivo è aumentato di oltre 380 miliardi di euro in un solo anno. Ma nessuno sembra interrogarsi sulla fonte di tale incremento: non proviene da un aumento di produttività o da nuove ricchezze create, bensì da un trasferimento forzato di risorse dal settore privato a quello pubblico. È il classico gioco a somma zero, in cui l’amministrazione statale appare più ricca solo perché i cittadini lo sono di meno. E ciò che viene giustificato come solidarietà è, nella sostanza, una forma di spoliazione legalizzata, che frena la libertà economica, la più concreta delle libertà civili.
Il caso italiano: laboratorio di statalismo fiscale
L’Italia, nel quadro sopra delineato, è un laboratorio perfetto di statalismo fiscale. Con un prelievo complessivo tra i più alti d’Europa e un debito pubblico che resta immutato, il sistema mostra la sua contraddizione di fondo: pretende più risorse proprio perché non riesce a produrne. È il paradosso di un Moloch statale che, non sapendo ridurre sé stesso, aumenta ciò che controlla. Le imposte diventano così lo strumento con cui la politica compensa la propria inefficienza. In pratica: più fallisce nel creare condizioni di prosperità, più reclama fondi per rimediare ai propri errori. È il cerchio vizioso del potere fiscale che trasforma la libertà economica in una concessione revocabile.
In sostanza, la tassazione eccessiva non è solo un problema di quantità, ma di concezione. Quando supera la soglia del necessario per finanziare le funzioni essenziali ˗ sicurezza, sanità, giustizia, infrastrutture ˗ essa diventa un mezzo di controllo sociale. Attraverso il bilancio pubblico lo Stato decide chi premiare e chi penalizzare, chi merita sussidi e chi deve pagare per mantenerli. In nome dell’uguaglianza, si costruisce una gerarchia artificiale che subordina la produttività all’obbedienza.
È questo il punto in cui la pressione fiscale si trasforma in questione di libertà. Come ha più volte annotato Friedrich A. von Hayek, la libertà non è compatibile con un potere capace di dirigere i fini degli individui: e nulla dirige di più dei flussi di denaro sottratti con la forza.
Le prove dei numeri: più tasse, meno crescita
Le analisi comunitarie dimostrano pure che la correlazione tra tasse elevate e qualità dei servizi pubblici è tutt’altro che lineare. In Francia o in Belgio, dove il prelievo supera il 45 per cento del Pil, la crescita resta debole e il debito alto. Nei Paesi con fiscalità più bassa, come Irlanda o Malta, l’occupazione cresce e il reddito pro-capite è superiore alla media europea.
Non si tratta di eccezioni, è piuttosto la logica conseguenza di un principio economico elementare: le risorse restano più produttive nelle mani di chi le crea che in quelle di chi le amministra. Il nodo politico è dunque chiaro: se si vuole davvero restituire vigore all’Europa, bisogna ridurre i compiti e le funzioni statali e degli apparati pubblici, non ampliarli. Non serve moltiplicare i sussidi, occorre eliminare gli ostacoli. Non bisogna creare nuovi prelievi, è necessario che i cittadini possano trattenere ciò che guadagnano. Ogni riforma fiscale che non parta da questo presupposto ˗ la centralità della proprietà e della responsabilità individuale ˗ è destinata a fallire, perché tenta di conciliare due principi inconciliabili: libertà e pianificazione.
La schiavitù gentile del fisco
In fondo, l’eccesso di tassazione è la forma moderna della servitù. Non impone catene visibili, impone piuttosto di lavorare ben oltre la metà della propria vita per lo Stato. È una schiavitù gentile, legalmente certificata che priva l’essere umano del frutto delle proprie scelte.
La libertà, invece, inizia dal diritto di disporre di sé e dei propri beni: senza questo fondamento, tutto il resto ˗ il voto, l’opinione, l’iniziativa ˗ diventa un’illusione amministrata. Ed è proprio in questa illusione che si annida la più sottile delle tirannie: quella che non ha bisogno di forza, ma solo di consenso.
Come ha scritto Étienne de La Boétie: “Non occorre combattere questo tiranno, né toglierlo di mezzo; si sconfigge da solo, a patto che il popolo non acconsenta alla propria servitù”.
E così, anche oggi, la libertà non muore per violenza, ma per abitudine: per la rassegnazione con cui si accetta che lo Stato disponga di ciò che si guadagna, decidendo in cambio cosa si debba pensare, produrre o credere.