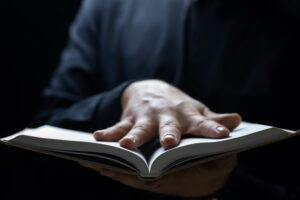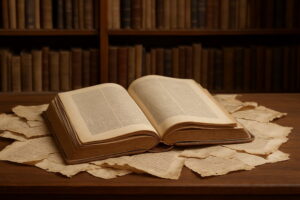Il debate rappresenta una prassi didattica diffusamente impiegata in diverse nazioni europee e, con consolidata tradizione, inserita nel curriculum delle scuole anglosassoni. Tale metodo consiste in un confronto dialettico scandito da regole e tempi rigorosamente stabiliti, nel quale due formazioni, ciascuna generalmente composta da tre o più discenti, sono chiamate a sostenere e confutare un enunciato o una questione specifica assegnata dall’autorità docente, schierandosi obbligatoriamente su una delle due posizioni senza possibilità di scelta autonoma. Poiché l’adesione a uno schieramento non riflette necessariamente le convinzioni intime circa l’argomento trattato, gli studenti si trovano sovente a difendere teorie non autenticamente care, né convinte. Si tratta perciò di un confronto articolato secondo precise norme, e non di una libera discussione; la varietà delle sue declinazioni non impedisce di riconoscere che, al fine di valorizzarne la funzione educativa, esso debba essere impiegato con flessibilità, evitando che la competizione divenga finalità suprema, ma considerandola invece uno stimolo agonistico puramente strumentale.
Le radici antiche della discussione dialettica
Questa metodologia dialogica, tuttavia, affonda le proprie origini in tempi remoti, potendo fregiarsi di illustri precedenti dal dibattito socratico-platonico fino alla celebre disputatio medievale. Se il riferimento al primo appare talora generico, è con la seconda che il legame si mostra più stringente. Nelle Accademie medioevali, infatti, la discussione rappresentava un fulcro imprescindibile dell’insegnamento. I testi venivano meticolosamente letti, analizzati e commentati nella fase nota come lectio. Il commento stimolava un dialogo che si emancipava dal testo per orientarsi verso la ricerca della verità. Come sottolinea Jacques Le Goff ne “Gli intellettuali nel medioevo”, «l’intellettuale universitario nasce nel momento in cui da passivo diventa attivo, quando comincia a mettere in discussione il testo, che è oramai solo un supporto quando si discute. Il maestro non è più un esegeta ma un pensatore».
Dalla scrupolosa lectio affiorava la quaestio, ovverosia il problema o il quesito da approfondire, da cui prendeva avvio la disputatio: un confronto serrato tra maestri e allievi che, a differenza del debate contemporaneo, si schieravano in favore della tesi che maggiormente li persuadesse.
La disputatio: il confronto orientato alla verità
La disputatio non si riduceva a una mera dimostrazione di abilità oratoria, bensì costituiva un metodico tentativo di progressione verso il vero, mediante l’esame dialettico di posizioni contrapposte. Come affermava Pietro Cantore nel XII secolo, «nessuna verità può essere veramente capita e predicata con ardore se prima non sia stata masticata dai denti della disputa».
Al contrario della disputatio, nel moderno debate si allena piuttosto la capacità di sostenere qualsivoglia tesi, anche se contraria alle convinzioni personali, abituando così gli studenti a impiegare la ragione per supportare posizioni prestabilite anziché, come nell’insegnamento socratico o medievale, per servire la ricerca della verità o la risoluzione più efficace di un problema. Il fine occulto del debate sembra essere quello di educare i giovani a considerare il linguaggio come mero strumento utile a qualsiasi scopo retorico, politica inclusa, intesa come carriera nella quale la padronanza oratoria diviene decisiva per conseguire successo e potere, anche attraverso la persuasione populista e demagogica.
Trattandosi di una tecnica disancorata dall’aspirazione alla verità o dalla risoluzione efficace di questioni di natura pratica, economica e sociale, tale pratica rischia di forgiare una nuova élite governante di persuasori politici i quali antepongono il proprio interesse al bene collettivo, favorendo una visione riduttiva della democrazia, come osservava Thomas Hobbes, definendola «un’aristocrazia di oratori». Sebbene la disputa mantenga indubbia utilità pedagogica, esercitando alla formazione, discussione e soluzione dei problemi, nonché all’individuazione euristica delle soluzioni più verosimili e alla confutazione degli errori, tali prerogative dovrebbero rimanere sempre inscindibilmente connesse a un fine giudicato «giusto», ovvero coerente con un sistema valoriale consapevole.
Argomentare senza un fine: la deriva retorica
La difficoltà cruciale nell’esercizio razionale non consiste dunque nel forgiare un’argomentazione efficiente, ma nel costruire un ragionamento funzionale a un fine previamente scelto e razionalmente definito. Ogni pratica argomentativa sprovvista di tale finalità rischia di ridursi a una mera operazione retorica asservita al miglior offerente, abituando così i cittadini a considerare la democrazia e il confronto dialettico come un mero marketing delle idee e dei valori politici, e contribuendo all’instaurarsi di una cultura relativista cinica e di un nichilismo latente destinato ad aggravarsi.
Per scongiurare simili esiti, basterebbe rifarsi al modello medievale, il quale prendeva avvio dalla lettura critica del testo (lectio), proseguiva con la definizione di un problema (quaestio) e si apriva alla discussione argomentativa (disputatio), al fine di stimolare in docenti e discenti un impegno congiunto nella riflessione e nella critica costruttiva. Così il potenziamento delle capacità argomentative manteneva costante l’obiettivo della ricerca della verità e della soluzione più adeguata, anziché limitarsi allo sviluppo di destrezza retorica nel sostenere a ogni costo una tesi assegnata o nel demolire quella contraria, pratica attualmente prevalente nel tentativo di dare forma all’aristocrazia oratoria che Hobbes aveva ammonito, con cui erroneamente si tende a identificare la democrazia.
Permane veritiero l’aforisma di Robert Pirsig: «La qualità non è mai un incidente; è sempre il risultato di uno sforzo di intelligente direzione».