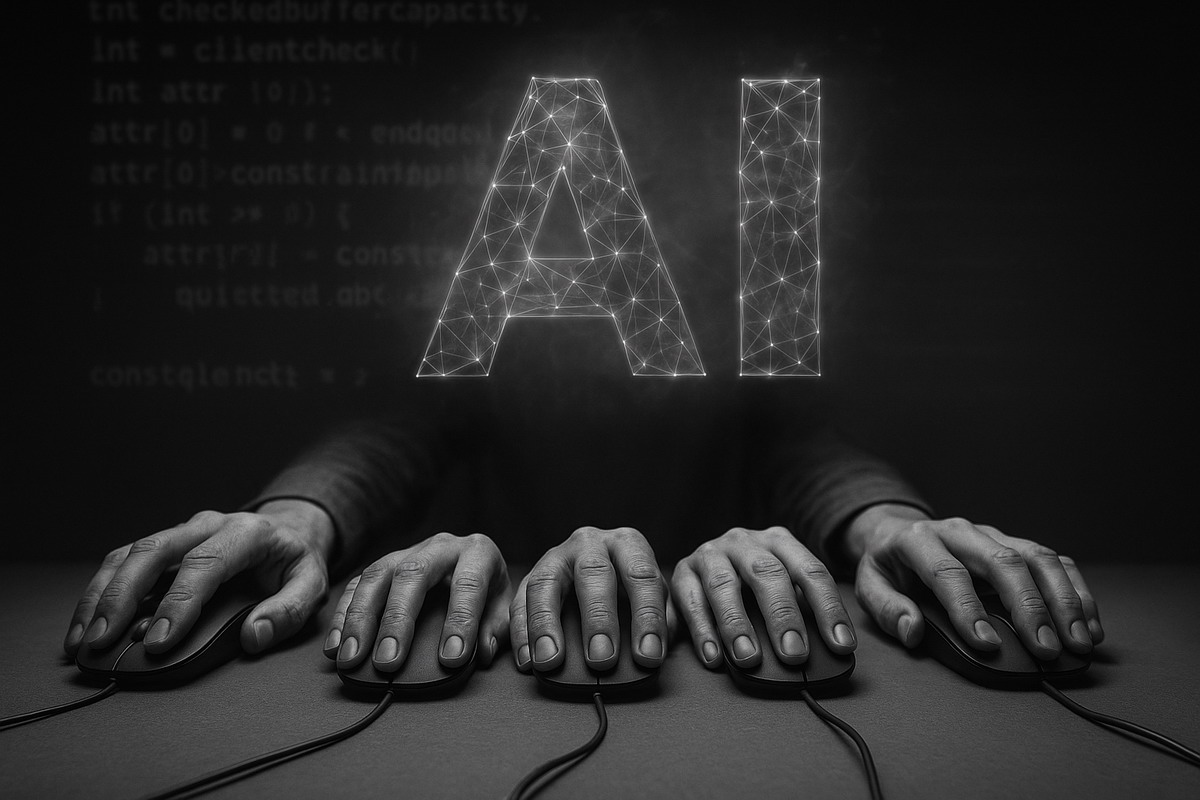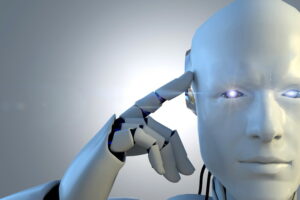L’Occidente ama raccontarsi favole sul progresso. Oggi la favola preferita ha un nome: intelligenza artificiale. Una tecnologia dipinta come autonoma, quasi magica, capace di emancipare l’essere umano dal lavoro. Ma dietro il mito dell’automazione c’è una polvere antica: esiste, nascosto ai più, un esercito di lavoratori invisibili, spesso pagati meno di un dollaro l’ora, che addestrano, filtrano, etichettano i dati da cui dipendono i nostri algoritmi.
Mary Gray e Siddharth Suri lo chiamano “ghost work”: la manodopera fantasma che sostiene il sogno dell’AI, collocata in India, Africa e Filippine. Non solo stipendi bassissimi, ma anche un prezzo psicologico altissimo, che non compare nei bilanci delle Big Tech. L’automazione, in verità, è un’illusione: l’AI vive di lavoro umano occultato, di fantasmi che non devono mai apparire nella narrazione ufficiale.
Dal cronometro di Taylor al clic algoritmico
I moderni server delle piattaforme digitali rievocano il taylorismo del Novecento: non più fabbriche rumorose, ma micro-task algoritmici assegnati a una moltitudine atomizzata. Maurizio Lazzarato già nel 1996 parlava di “lavoro immateriale”: capacità cognitive e affettive asservite a logiche industriali. Antonio Casilli nel 2019 smascherava la realtà: mentre ci raccontiamo di essere “in attesa dei robot”, i veri robot siamo noi, addestrati a cliccare e correggere, alimentando il mito dell’automazione.
H. Konuk (2023) ha mostrato come questa digitalizzazione del lavoro generi ansia, alienazione, stress psicologico. È un taylorismo digitale più subdolo: non imprigiona il corpo in fabbrica, ma colonizza la mente davanti a uno schermo. Dal cronometro di Taylor siamo passati al dashboard algoritmico: cambia lo strumento, resta identico lo sfruttamento.
I nuovi sweatshop digitali
La scala dello sfruttamento è impressionante: la workforce globale dell’AI conta tra 154 e 435 milioni di gig workers. Solo il mercato del data annotation raggiungerà 8,22 miliardi di dollari nel 2028. Bostanci & Yilmaz (2025) parlano di veri e propri “digital sweatshop”: catene di montaggio che non puzzano d’olio, ma di silicio e disperazione.
Un data labeler del Sud globale guadagna tra 140 e 560 dollari al mese; un ingegnere di San Francisco prende 50-70 dollari l’ora. La retorica della “flessibilità” è solo la maschera di una realtà precaria, senza garanzie né tutele. Nessuna ferie, nessuna malattia, nessuna voce.
Colonialismo digitale: il ritorno del rimosso
Nick Srnicek ha spiegato come il capitalismo delle piattaforme sia una macchina di estrazione: profitti al Nord, costi scaricati al Sud. La Partnership for Economic Policy (2024) parla di “nuova divisione internazionale del lavoro digitale”: alta specializzazione nei paesi ricchi, micro-task nei paesi poveri.
La comparazione storica è inevitabile: se nell’Ottocento le colonie fornivano cotone, oggi forniscono dati. Nayak (2024) lo dice chiaramente: big data e AI non sono innovazione neutra, ma nuove forme di accumulazione capitalistica che riproducono logiche coloniali. Il colonialismo non ha più le navi, ma i data center; non ha più piantagioni di cotone, ma piantagioni di clic.
Il trauma come materia prima
Non tutti i ghost worker etichettano gattini. Molti sono impiegati nella moderazione di contenuti violenti, pornografici o propagandistici, per pochi centesimi e per ore, rischiando seriamente la salute mentale. Shoshana Zuboff parlava di “capitalismo della sorveglianza”: qui la sorveglianza si abbatte proprio sui lavoratori, obbligati a guardare il lato oscuro del web per proteggere la società digitale.
Nei convegni sull’etica dell’AI si discute sorseggiando Chardonnay, mentre a Nairobi qualcuno passa otto ore a guardare video di decapitazioni. Questa è la vera asimmetria del progresso.
Free labour: la grande illusione
L’economia digitale vive anche di lavoro gratuito o sottopagato mascherato da partecipazione: lo aveva già notato Tiziana Terranova nel 2000. Il mito dell’automazione serve a legittimare questa realtà. Mostrare all’opinione pubblica che dietro ogni algoritmo c’è lavoro umano sottopagato farebbe crollare la narrazione, e forse anche i bilanci.
Una questione politica aperta
Non è un destino ineluttabile: tutto dipende da scelte politiche. In Europa, il progetto Ghostwork (ERC 2022-2027) prova a rendere visibile chi lavora dietro le piattaforme, proponendo nuove forme di tutela. Servono trasparenza nelle filiere AI, riconoscimento dei diritti, proprietà collettiva dei dati prodotti da lavoro umano.
Ci sono alternative: cooperative digitali, piattaforme worker-owned, sindacalizzazione online. Ma senza una vera spinta politica, il futuro del lavoro sarà scritto da algoritmi ciechi alla dignità umana.
Il fantasma nella macchina
L’AI non è autonoma. È una macchina che funziona perché milioni di persone la alimentano, invisibili e sfruttate. Sono loro, i fantasmi del nuovo capitalismo, eppure sono l’ingranaggio essenziale.
Come scrivevano Gray e Suri, non si può parlare di intelligenza artificiale senza parlare di ghost work. La verità è che l’AI non è né artificiale né intelligente: è solo un capitalismo che ha imparato a chiamare “fantasmi” i suoi schiavi.