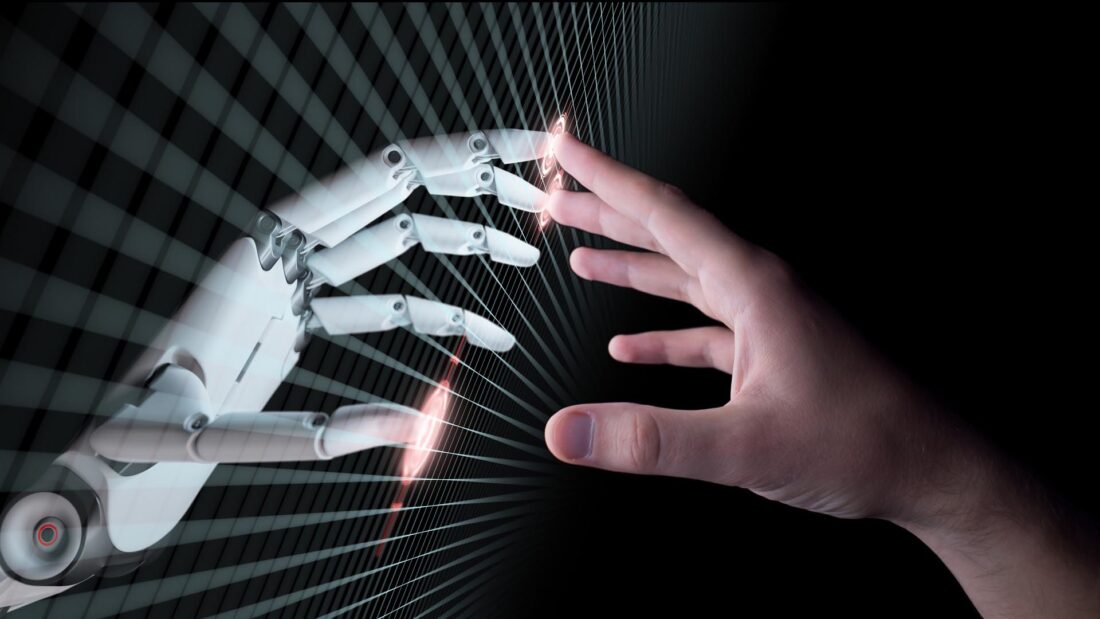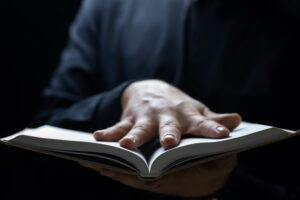Questo articolo nasce dalla lettura di un pezzo dal titolo eloquente, pubblicato sul New York Times: “So Long to Tech’s Dream Job”. La tesi è semplice: siamo entrati nella “shut up and grind era” – l’era del “zitto e macina”. Via l’epoca dorata di Google, Meta e Apple con campus da sogno e culture say-anything, do-anything. Oggi sono “grandi burocrazie” che “tagliano posti di lavoro, impongono presenza obbligatoria in ufficio e limitano il dibattito tra dipendenti”.
Un racconto preciso di una Silicon Valley che ha perso l’innocenza. Ma qui rischiamo di importare un dibattito che non ci appartiene. Perché il punto non è piangere la fine dei Nerf gun negli uffici di Mountain View. È capire cosa questa transizione significa per l’Italia, che di quell’età dell’oro non ha mai fatto parte.
La storia in tre righe
Non è la fine del lavoro informatico: stiamo assistendo a una normalizzazione dopo anni “dopati” da capitali a costo quasi zero e over-hiring. L’AI non sostituisce in blocco le persone: ristruttura i processi e cambia il mix di competenze. In Italia il vero freno è istituzionale e culturale: fisco e burocrazia da “socio di maggioranza” e software visto come costo, non come capitale.
La festa è finita (ma la musica continua)
L’epoca dorata è durata oltre un decennio. Dal 2007 Google regalava bonus natalizi da mille dollari in busta paga, campus con palestre gratuite e trasparenza aziendale totale. Negli anni 2020-2022 è arrivato il gran finale: assunzioni a raffica con capitali a costo zero, benefit senza limiti. Un developer poteva chiedere un aumento il lunedì e riceverlo il mercoledì. Le startup distribuivano equity come caramelle ad Halloween.
Poi la realtà ha bussato alla porta. Tassi al rialzo, fine dei benefit illimitati, baricentro che si sposta da crescita a margini. Ma i numeri della Bay Area raccontano una storia diversa dal panico: il motore gira ancora forte, ha solo smesso di andare fuorigiri. Meno assunzioni nette, più selettività, redditività alta. Non è collasso, è il passaggio da eccesso a normalità.
La disoccupazione IT negli Stati Uniti resta al 2,8-3 per cento. Bassa. La domanda c’è, ma è diventata esigente: competenze verificabili, seniority documentata. Più difficile per i junior, certo, ma non è il deserto che descrivono alcuni titoli di giornale.
Intanto l’organizzazione del lavoro si è stabilizzata: ibrido strutturale, presenza fisica sotto il 50 per cento, talento distribuito geograficamente. Meno centralità dei campus stellari, più catene del valore estese. Traduzione: fine dei fuochi d’artificio, non fine dei giochi.
L’AI non è una falce livellatrice
Qui bisogna essere precisi. L’intelligenza artificiale ridisegna processi, mansioni, tempi. Ma gli studi macro parlano chiaro: forte impatto di complementarità. In molte attività cognitive l’AI amplifica la produttività e alza il livello delle competenze richieste. Non sostituisce intere funzioni: le trasforma.
Il punto non è “posto sì, posto no”. È contenuto del lavoro e composizione delle squadre. Immaginate un consulente che prima impiegava tre giorni per scrivere un report di mercato. Con l’AI lo fa in mezza giornata, ma ora può produrne sei di qualità superiore nello stesso tempo. Il suo valore non diminuisce: si moltiplica.
Le aziende che reggono non fanno “taglia e sostituisci con AI”. Fanno re-ingegnerizzazione: eliminano strati ridondanti, spostano persone su ideazione e controllo qualità, investono in piattaforme dati e automazione intelligente. Nelle fasi iniziali, l’effetto è più ricomposizione che sostituzione pura.
Sì, esistono licenziamenti attribuiti all’AI. Ma convivono con profitti robusti e nuova domanda di profili specializzati. Pensare all’AI come falce livellatrice è comodo ma sbagliato. È una tecnologia generale che ristruttura filiere intere, come fecero l’elettrificazione o Internet.
L’Italia è un’altra storia (e il problema non è l’AI)
Qui il problema non è l’AI “che toglie lavoro”. È che non abbiamo mai avuto una vera età dell’oro del software. Siamo partiti in ritardo e abbiamo corso male.
Prendete il fisco: un developer italiano che guadagna 40mila euro ne vede arrivare a casa poco più della metà. Il resto va allo Stato, che diventa il vero socio di maggioranza di ogni azienda tecnologica. Cuneo fiscale al 47 per cento, quarto posto OCSE. Il lavoro qualificato costa tanto, scoraggia crescita e premi al merito. Risultato: talento che scappa verso Londra o Berlino, aziende che non investono.
Poi c’è il deserto digitale. Solo il 46 per cento della popolazione italiana ha competenze digitali di base. Media europea: oltre il 55 per cento. Con questa base ristretta, domanda e offerta si contraggono a vicenda. È difficile vendere soluzioni digitali a un paese che fatica a usare l’home banking.
Ma il vero problema culturale è come trattiamo il software: male necessario da comprimere, non investimento che genera produttività. Basta guardare i budget IT della pubblica amministrazione: manutenzione infinita di sistemi obsoleti, zero prodotto, zero innovazione. Milioni spesi per tenere in vita dinosauri informatici invece di costruire servizi che funzionano.
Le filiere IT italiane restano ancorate a logiche “anni novanta”: progetti a corpo invece di prodotti scalabili, consulenza infinita invece di responsabilità sul risultato. Con questo assetto, portare l’AI è come mettere un motore da Formula 1 su una Panda del 1992. Il potenziale c’è, ma mancano le fondamenta.
Cosa fare (piano concreto, zero ideologia)
Primo: trattare il software come capitale, non come spesa. Super-ammortamento stabile per investimenti in sistemi, dati, modelli AI. Non solo hardware. Vincolo: rendicontazione di produttività a 24-36 mesi. Se compri un software che ti fa risparmiare il 20 per cento di tempo, devi dimostrarlo con i numeri.
Secondo: ridurre il cuneo sul talento critico. Meccanismo automatico per profili STEM e AI sopra una certa soglia salariale. Legato a permanenza e formazione interna. Non bonus a pioggia, ma incentivo selettivo e misurabile per chi porta valore aggiunto.
Terzo: procurement pubblico che premia risultati. Invece di comprare “consulenza per lo sviluppo di sistema di gestione documentale”, comprare “riduzione del 50 per cento dei tempi di risposta ai cittadini”. Pagare per gli outcome, non per le ore. Repository condivisi, proprietà dei modelli, benchmark per evitare di rimanere prigionieri di un fornitore.
Quarto: capitale umano serio. Obiettivo: 55 per cento di competenze digitali di base in due anni. Tirocini pratici su gestione dati, sicurezza, automazione intelligente. L’AI senza disciplina operativa rimane marketing.
Quinto: infrastruttura dati con regole chiare. Cataloghi interoperabili, policy comprensibili su privacy e tracciabilità. Template di conformità, non “terrorismo documentale” che paralizza tutto. Se un’azienda vuole usare l’AI per migliorare il servizio clienti, deve sapere subito cosa può e non può fare.
Sesto: misurare sempre. Ogni progetto AI presenta tre metriche prima di partire: tempo ciclo, errori, ore sprecate. Audit indipendente dopo. Senza numeri, l’AI resta comunicato stampa da ufficio marketing.
Cosa significa per chi lavora nell’IT
La regola è semplice: non temere la macchina, temere la mansione ripetitiva. La difesa non sta nel tool del momento, ma nel perimetro di problemi che risolvi dall’inizio alla fine. Un bravo developer non è quello che scrive più righe di codice, ma quello che risolve problemi veri con il minor spreco di risorse.
Puntare su integrazione e proprietà del risultato. Imparare a progettare prompt è utile, ma orchestrare processi, definire metriche e far funzionare insieme persone e modelli è decisivo. L’AI è il tuo assistente più intelligente, non il tuo sostituto.
Portare l’AI nel lavoro quotidiano significa eliminare un collo di bottiglia ogni settimana: automatizzare ticket ripetitivi, migliorare qualità dei test, generare report che prima richiedevano ore. Regola pratica: meno click, più risultati.
E soprattutto, imparare a parlare ROI. Tradurre ogni investimento software in risultato misurabile: minor tempo ciclo, meno errori, dati più affidabili. Spiegare ai manager come la spesa di oggi diventa l’asset di domani. Chi sa fare questo non avrà mai problemi a trovare lavoro.
Da spettatori a protagonisti
L’AI è come l’elettrificazione: non sostituisce “le persone”, ricombina organizzazioni e competenze. In America vediamo normalizzazione dopo eccessi: meno hype, più disciplina operativa, profitti alti e sostenibili.
In Italia, senza riforme fiscali, procurement moderni e investimenti seri in capitale umano, l’AI resterà una semplice vetrina. Un altro caso di tecnologia importata e mal digerita, come è successo troppe volte negli ultimi vent’anni.
Ma se cambiamo contesto, l’AI diventa la leva per passare dal software-costo al software-capitale. Per dimostrare che l’innovazione non è un lusso per tempi grassi, ma la conditio sine qua non per competere. Allora non avremo bisogno di americani che vengano a spiegarcelo: lo costruiremo noi.
Sta a noi decidere se cogliere questa opportunità o rimanere spettatori di un cambiamento che corre veloce senza di noi. La tecnologia c’è, i talenti pure. Manca solo la volontà di smettere di lamentarci e iniziare a costruire.