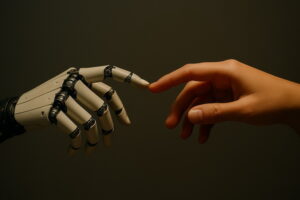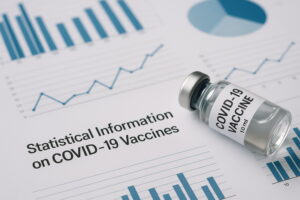Ci sono momenti storici in cui una lingua torna a reclamare la propria centralità non come reliquia, ma come forza attiva della civiltà. La Conferenza Italofonia di Roma è stata esattamente questo: un tornante culturale, una soglia simbolica, un punto di riaggregazione per una comunità che esisteva da tempo ma che non aveva ancora piena coscienza di sé.
La nascita ufficiale della Comunità dell’Italofonia rappresenta l’emersione politica di un fenomeno culturale profondo: milioni di persone nel mondo si riconoscono nell’italiano non per passaporto o genealogia, ma per identità, affinità, scelta. Una comunità fondata sulla adesione, non sul sangue; sulla relazione, non sull’imposizione; sulla bellezza, non sull’egemonia.
In un mondo che tende a semplificare, standardizzare e omologare, l’italiano torna invece a proporre complessità, sfumatura, intelligenza emotiva. E lo fa con la naturale grazia che da secoli lo contraddistingue.
Le parole che hanno definito un orizzonte
Giorgia Meloni: “Ogni parola è una scena, ogni frase un capolavoro.”
La Presidente del Consiglio ha consegnato all’Italofonia una delle immagini retoriche più efficaci degli ultimi anni:
“La lingua italiana non è solo uno strumento di comunicazione, ma un film: ogni parola è una scena e ogni frase un capolavoro.”
Non è una metafora ornamentale: è un’intuizione culturale precisa.
L’italiano non descrive: mette in scena.
Non registra il mondo: lo rappresenta.
È una lingua performativa, teatrale, visiva, narrativa.
Da Dante a Visconti, da Leopardi a Sorrentino, l’italiano è sempre stato un dispositivo estetico oltre che un codice linguistico.
Richiamarlo oggi significa riconoscere che la forza di una lingua non sta nella sua quantità, ma nella sua qualità espressiva.
Antonio Tajani: “Lingua di pace, dialogo e scambio.”
Il Ministro degli Affari Esteri ha aggiunto una prospettiva strategica: “L’italiano è una lingua di pace, di dialogo, di scambio culturale ed economico.”
In un’epoca in cui molte lingue arrivano nel mondo accompagnate dal peso di potenze geopolitiche, l’italiano si presenta come lingua non imperiale, capace di dialogare senza dominare, di costruire ponti senza pretendere tributi.
È la lingua dell’umanesimo e dell’impresa culturale, del design e dell’alta formazione, dell’arte e dell’ingegneria.
Una lingua che non conquista territori: conquista menti.
Andrea Riccardi e la Dante Alighieri: la lingua come umanesimo contemporaneo
In questo quadro si inserisce la voce autorevole di Andrea Riccardi, presidente della Società Dante Alighieri, che ha ricordato come l’italiano sia «una lingua che rappresenta l’umanesimo e che unisce».
Riccardi non indulge mai nella retorica. Le sue parole sono affilate: “Non siamo ingenui: sappiamo che la lingua italiana non è imperiale… ma non è neanche una lingua provinciale. Provinciale è l’atteggiamento rinunciatario verso la lingua.”
È una dichiarazione cruciale.
Riccardi rifiuta l’idea di un’Italia che si rassegna all’irrilevanza linguistica nel nome del cosmopolitismo malinteso.
Ricorda che la lingua non è un vezzo estetico: è un’infrastruttura mentale, un ponte culturale, un vettore economico.
E soprattutto aggiunge un punto decisivo: “La lingua e la cultura italiane rappresentano l’umanesimo e sono capaci di unire, di promuovere il dialogo e di creare ponti oltre i confini nazionali, anche grazie all’italofonia degli stranieri in Italia.”
Qui si intravede il vero potenziale dell’Italofonia: una comunità globale, plurale, aperta, che non parte dall’Italia, ma si irradia dal mondo, dagli italofoni non italiani, dalle nuove generazioni che scelgono l’italiano come codice culturale e identitario.
La vera innovazione dell’italiano: antica, diversa, elegante, compiacente
Molti immaginano che l’innovazione linguistica appartenga alle lingue giovani, snelle, tecniche.
Ma è un pregiudizio.
L’italiano dimostra l’opposto:
È una lingua antica, ma non è mai stata una lingua vecchia.
È un linguaggio che accoglie senza perdere l’identità; che assorbe senza dissolversi; che trasforma senza snaturarsi.
È una lingua che sa ospitare l’AI, la robotica, la matematica, la poesia, il cinema, il teatro, il design, la diplomazia, l’impresa, l’innovazione scientifica.
La sua forza non è l’uniformità, ma la sfumatura.
Non la velocità, ma la precisione.
Non il minimalismo, ma la ricchezza armonica.
Questa non è fragilità: è una forma di resilienza linguistica, più utile oggi che mai, quando l’intelligenza artificiale tende a semplificare il pensiero e ridurre la complessità.
L’italiano, invece, la amplia.
Italofonia come querelle culturale: una lingua che pensa
L’Italofonia non è solo un progetto politico né un’iniziativa diplomatica.
È un terreno di discussione, una querelle culturale nel senso più nobile del termine: un dibattito vivo sul ruolo della lingua come:
- mezzo di comunicazione,
- strumento di conoscenza,
- piattaforma identitaria,
- vettore di civiltà.
La Comunità dell’Italofonia potrà diventare:
- uno spazio di cooperazione accademica;
- un luogo di scambio culturale;
- una rete di ricerca;
- un ponte tra istituzioni e comunità;
- un laboratorio linguistico globale.
La sfida non è solo celebrare l’italiano: è renderlo utile.
Utile alle imprese, alla scienza, alla cultura, alla tecnologia, all’integrazione sociale, alla formazione, alla diplomazia culturale.
La mia esperienza personale: una lingua che pensa oltre il tempo
Ho partecipato alla Conferenza Italofonia con uno sguardo personale, portando con me anni di esperienza nel mondo dell’innovazione, della tecnologia e della strategia.
Eppure, ciò che ho percepito più forte non è stato l’aspetto politico dell’evento, ma quello cognitivo.
La lingua italiana ha una qualità rara: consente di pensare in verticale, non solo in orizzontale.
Costringe alla precisione, ma apre alla creatività.
Non sistemi il mondo con un colpo secco: lo ricomponi con cura.
In un’epoca in cui il linguaggio globale tende a diventare piatto, immediato, transazionale, l’italiano offre l’opposto:
- profondità,
- ritmo,
- musicalità,
- complessità utile.
La lingua è un modo di vedere.
E l’italiano vede ancora lontano.
Ho percepito che l’innovazione non è solo nelle tecnologie che progettiamo, ma nel linguaggio attraverso cui le pensiamo.
E in questo, l’italiano offre un vantaggio competitivo invisibile, ma reale: un pensiero più ordinato, più estetico, più completo.
L’Italiano come motore di civiltà
La Conferenza Italofonia non ha semplicemente celebrato la nostra lingua: ha suggerito un destino possibile.
Non quello di un idioma museale, né quello di una lingua-minore resistente.
Bensì quello di una lingua civiltà:
un codice capace di dare forma a un modo di pensare, di conoscere, di creare, di incontrare l’altro.
Riccardi ha ragione: l’italiano non è imperiale, ma non è neppure provinciale.
È un ponte.
Un territorio mentale.
Una promessa culturale.
È un invito a guardare il mondo con occhi più profondi.
Un film in cui ogni parola è una scena, e ogni frase un capolavoro.
E noi, italofoni del mondo – per nascita, per scelta o per amore – siamo chiamati a renderlo vivo, utile, innovativo, contemporaneo.