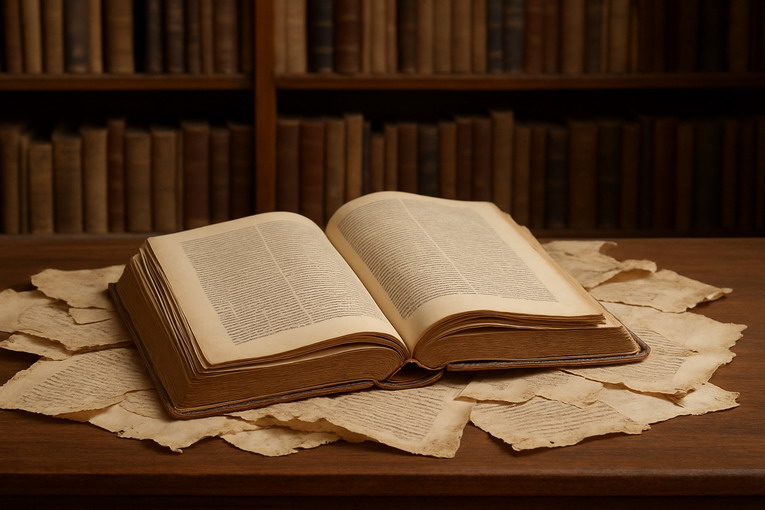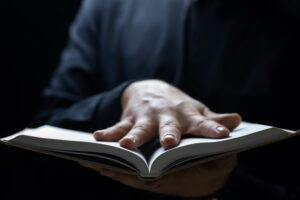“Molte sono le cose mirabili, ma nulla è più mirabile dell’uomo”, un’epigrafe che Sofocle ci ha lasciato nell’Antigone, risuona ironica di fronte all’incredibile capacità distruttiva che l’umanità ha esercitato non solo verso i propri consimili, ma anche a scapito del proprio stesso patrimonio intellettuale. La letteratura antica, summum opus della sensibilità e della mente umane, è stata in vasta parte abrogata dal corso storico, lasciandoci solo un’eco flebile di un cosmo culturale ormai inabissato. Gli studiosi stimano che l’ammontare della produzione letteraria greca e latina pervenuta sino a noi si attesti al meno del 10%. L’ingente residuo — costituto da trattati filosofici, scientifici, drammaturgici e lirici — è svanito, sotterrato dall’incuria, dall’intolleranza o, semplicemente, dalla labilità dei supporti materiali.
Eziologia della catastrofe antica
La genesi della perdita del retaggio letterario classico è multifattoriale: in primo luogo, nell’intrinseca fragilità del papiro e nella negligenza delle ere susseguenti. Un ruolo dirimente fu giocato dalla trasformazione ideologica che investì l’Impero Romano con l’avvento del Cristianesimo. Tale mutamento di paradigma culturale, transitando dal pluralismo intellettuale del mondo classico al monoteismo intollerante delle prime fasi cristiane, costituì una svolta drammatica. Intere istituzioni depositarie del sapere, quali la Biblioteca di Alessandria, quella di Pergamo e quella di Atene, furono sistematicamente saccheggiate, incendiate o abbandonate.
Il meccanismo di trasmissione, affidato agli amanuensi medievali (l’unica via per la tradizione dei testi), operò un drastico vaglio. Molti codices furono scientemente pretermessi, poiché giudicati “pagani,” “eretici,” o addirittura “inutili”.
Le mutazioni del corpus filosofico e poetico
Il caso di Aristotele illustra emblematicamente questa mutilazione del sapere. Le sue opere “essoteriche” (destinate, come suggerisce il greco “esteriore, accessibile”, al pubblico generale) sono pressoché scomparse. Ciò che ci rimane è il corpus scolastico: un insieme di trattati tecnici, sovente lacunosi che ci trasmette un’immagine parziale e distorta dell’architettura concettuale del filosofo.
Similmente, di Saffo, la celebrata “decima Musa,” permangono soltanto esigui frammenti. La sua lirica, che enunciava l’amore e la bellezza attraverso una voce femminile singolare per l’antichità, fu oscurata non solo dall’erosione temporale, ma anche da secoli di implicita censura, i quali non seppero accogliere l’intimità del suo sguardo. Figure gigantesche della filosofia, come Crisippo, Plotino, Epitteto e Epicuro, sono per noi quasi interamente assenti, noti solo attraverso frammenti indiretti. L’Occidente ha quindi edificato la propria identità speculativa su un substrato parziale, carente di visioni che avrebbero potuto propinare alternative significative sull’etica e il cosmo.
La precarietà digitale: un nuovo spettro?
Dobbiamo, nondimeno, rendere merito al lavoro meticoloso degli amanuensi. Senza la loro opera, l’eredità letteraria sarebbe incorsa in una completa estinzione. Tuttavia, anche il loro discernimento, conscio o inconscio, generò la sostituzione culturale: i palinsesti, testi obliterati per accogliere nuove scritture, ne costituiscono la metafora perfetta.
Nel contesto del XXI secolo, la fragilità non risiede più nella pergamena, ma si annida nei supporti digitali. Un file obsoleto, un server desueto, un formato proprietario dimenticato possono sancire la
cancellazione perenne di intere cognizioni. Il digitale, a meno che non sia sistematicamente duplicato, conservato in una pluralità di formati e costantemente aggiornato, rischia di rivelarsi meno perenne del supporto cartaceo. L’esperienza comune, come dimostra l’impossibilità di accedere a dati immagazzinati su dischetti da 3,5” o CD, attesta questo pericolo.
L’epurazione ideologica contemporanea
Se l’antica letteratura soccombette all’intolleranza religiosa, l’epoca odierna manifesta una nuova tipologia di epurazione: una censura ideologica mascherata sotto l’egida della virtù civile. Le sedi del sapere, dalle fiere del libro alle università, si stanno trasformando nel teatro di una nuova inquisizione. Autori considerati scomodi, voci non allineate o pensatori eterodossi vengono zittiti attraverso metodi subdoli. Questi includono la pressione esercitata sugli editori, i disinviti o la rimozione silenziosa di volumi dai cataloghi. Questa logica è giustificata con la necessità di una “sicurezza emotiva,” asserendo di proteggere l’uditorio da concetti perturbanti. Ciononostante, questa protezione si configura quale un’effettiva coercizione del pensiero, replicando dinamiche millenarie.
I grandi conglomerati editoriali perseguono linee sempre più omologate. Il pluralismo è spesso ridotto a mera facciata. Il dissenso è ammesso solo finché rimane inoffensivo. Le opinioni dissonanti non vengono recensite, ignorate omesse dalla ristampa. Il controllo non è più retto da una censura esplicita, ma dalla selezione algoritmica e da una dilagante autocensura preventiva.
Paradossalmente, mentre si invoca la “libertà di stampa,” i giornalisti non godono più della “libertà di scrittura,” essendo costretti ad aderire alla linea politica editoriale. Non vi è dunque necessità di un’azione censoria esterna, essendo essa già internalizzata.
L’imperativo della discordanza
Come nell’antichità furono preservati unicamente i testi compatibili con la nuova visione del mondo, oggi si promuove solo ciò che non perturba l’establishment culturale. La cultura, in tal modo, diviene prescrittiva, ancillare e manifesta l’incapacità di contenere le contraddizioni intrinseche al pensiero. Si assiste alla diffusione di una monocultura ideologica che si traveste da progresso.
Si domanda: é tollerabile che ciò che risulta scomodo venga relegato al silenzio? Il dovere delle istituzioni e delle generazioni attuali non si dovrebbe limitare alla mera produzione culturale, ma si dovrebbe estendere alla preservazione della libertà d’espressione, alla custodia del dissenso e all’archiviazione persino dell’errore.
Ogni voce che venga oggi cancellata costituirà, in futuro, un’assenza irreparabile. Se il naufragio culturale del passato può essere considerato, almeno in parte, un epifenomeno inevitabile, quello del presente non lo è affatto.