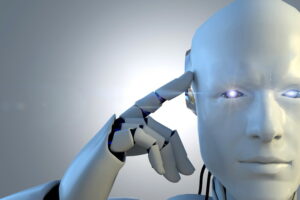Il recente accordo tra Unione Europea e Stati Uniti ha sollevato forti polemiche per le sue implicazioni economiche, industriali e geopolitiche. Tra dazi imposti sui prodotti europei, massicci investimenti in armamenti e acquisti vincolanti di energia americana, molti cittadini e analisti iniziano a chiedersi: che fine ha fatto la sovranità economica dell’Europa? E, più nello specifico, quella dell’Italia?
Unione Europea e Stati Uniti: un’intesa squilibrata
Nel cuore dell’accordo Ursula–Donald, emerge un paradosso: l’Unione Europea si impegna ad acquistare 250 miliardi di dollari l’anno in petrolio e gas dagli Stati Uniti – energia più costosa e più inquinante – mentre continua a ripetere che i combustibili fossili debbano essere abbandonati per affrontare la crisi climatica. Una contraddizione evidente, che mina la coerenza delle politiche ambientali dell’UE, aggravando nel contempo i costi energetici per le imprese europee.
In parallelo, l’UE ha previsto 600 miliardi di euro di investimenti in armamenti nei prossimi tre anni. Una cifra impressionante, soprattutto se confrontata con i continui tagli subiti negli anni da settori vitali come sanità, istruzione, giustizia e welfare.
Industria europea sotto assedio: tra dazi USA e Green Deal mal gestito
L’introduzione di dazi del 15% sui prodotti europei esportati negli Stati Uniti rappresenta un colpo durissimo per la manifattura italiana, in particolare per settori strategici come automotive, meccanica e agroalimentare. Una misura che non trova reciprocità: i prodotti americani continuano ad entrare nel mercato europeo senza imposizioni doganali.
A tutto ciò si aggiunge la rigidità del Green Deal europeo, un’iniziativa lodevole negli obiettivi ma devastante nelle modalità di applicazione. L’industria automobilistica europea, ad esempio, è stata messa in ginocchio da normative troppo drastiche e rapide, senza un’adeguata transizione per le imprese.
La crisi della sanità, della scuola e delle pensioni
Mentre si trovano miliardi per armi e importazioni energetiche, la sanità pubblica è allo stremo. Liste d’attesa infinite, carenza di personale, strutture fatiscenti: il diritto alla salute è sempre più un privilegio. La scuola non è da meno: i progetti di alternanza scuola-lavoro continuano a mietere vittime, mentre i docenti sono sottopagati e demotivati.
Anche le pensioni restano una ferita aperta: con assegni spesso inferiori a 600 euro mensili, moltissimi anziani vivono in condizioni di povertà assoluta, invisibili agli occhi della politica.
Un’Italia che emigra e si impoverisce
Nel 2024, quasi 200.000 italiani hanno lasciato il Paese per cercare condizioni di vita migliori all’estero. Un dato drammatico, che riflette la mancanza di opportunità e l’insostenibilità del costo della vita, soprattutto per i giovani. I salari stagnano, la precarietà è la norma, e anche chi lavora spesso non riesce ad arrivare a fine mese.
Questione morale, politica e di sovranità
Questa situazione non è solo economica: è profondamente politica e morale. L’Italia, repubblica fondata sul lavoro, oggi è un Paese dove si muore di lavoro, dove la giustizia è percepita come inefficiente, dove la disparità salariale tra uomo e donna persiste, e dove i diritti costituzionali vengono sistematicamente ignorati.
Quale Europa vogliamo?
A fronte di un’Europa che pare diventare sempre più strumento geopolitico degli Stati Uniti, cresce la richiesta di un’Europa diversa: non quella delle armi, dei dazi e della burocrazia, ma un’Europa dei popoli, che metta al centro i cittadini, la dignità del lavoro, i servizi essenziali.
Conclusione: reagire è un dovere
Oggi l’Italia si trova davanti a un bivio: subire o reagire. Continuare a rassegnarsi, credendo che non ci siano alternative, o ritrovare il coraggio di lottare per un futuro migliore. L’indignazione, la partecipazione, il voto consapevole e l’impegno civico sono gli unici strumenti per recuperare dignità, diritti e speranza. Perché senza speranza non c’è futuro. E senza futuro, non c’è Italia.