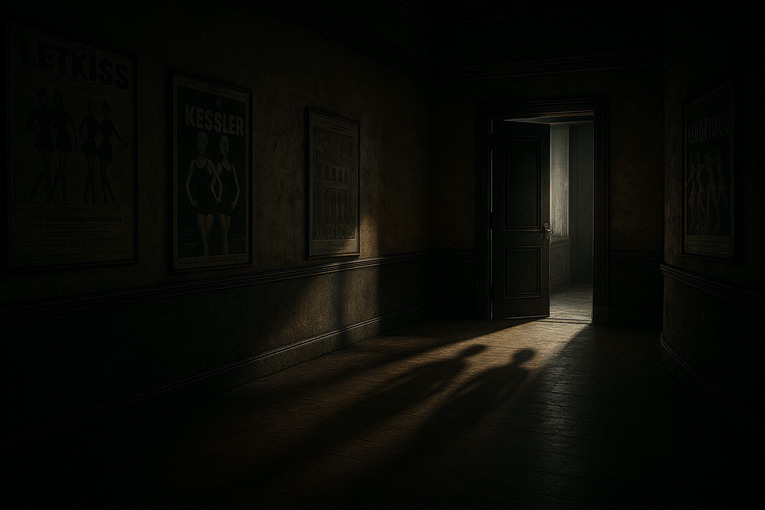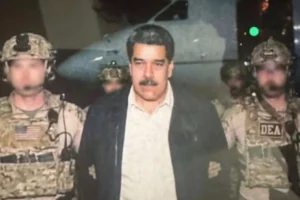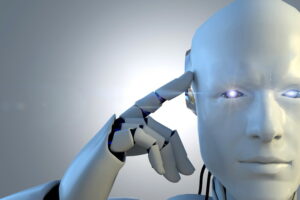Nella nostra epoca, nella quale la realtà si liquefà nello scintillio degli spettacoli, perfino la morte s’abbandona a una morbosa esibizione. Il gesto estremo compiuto dalle gemelle Kessler, orchestrato con cura maniacale, corredato da disposizioni sull’urna e da minuzie pratiche come la cancellazione dell’abbonamento al giornale nel giorno stabilito, manifesta una dissonanza angosciante: ciò che fu splendore, danza e giovinezza si chiude nel silenzio pianificato di un addio che pretende l’eleganza di una scena conclusiva.
La solitudine dietro la perfezione
Le due figure, per decenni simbolo di armonia e leggerezza nel periodo del boom, si spengono con un rigore che inquieta. Non erano povere né manifestamente inferme, tuttavia hanno scelto la fine come atto deliberato. Dietro la compostezza organizzativa si intravede una tristezza che ha perduto la forza di chiedere aiuto, un vuoto che non trova parole né corde a cui aggrapparsi: la stanchezza di un tempo che non restituisce più luci, l’erosione di ogni progetto affettivo, la solitudine che diviene abisso anche quando è condivisa. Davanti a tale mistero, il primo dovere è il rispetto: ridurre il commiato di due donne a un aneddoto sensazionalistico sarebbe una violenza ulteriore, un’offesa al segreto ultimo del cuore.
Eppure la reazione pubblica ha tradito quella compassione. I mezzi di comunicazione che trasformano in evento ogni frammento di vita, hanno eretto il suicidio a spettacolo, celebrandone la forma con parole leggere e ammiccanti.
Il circo mediatico e i suoi toni compiaciuti
Il Corriere della Sera ha consegnato alla vicenda una risonanza paragonabile a grandi avvenimenti nazionali, dedicando all’episodio persino nove pagine e offrendo interpretazioni che oscillano dall’ammirazione al compiacimento; Massimo Gramellini ha parlato dell’ultimo passo come di un rito, una “uscita di scena” preparata con cura, trasformando il dolore in immagine teatrale. Altri quotidiani hanno enfatizzato la presunta modernità dell’atto, “hanno dimostrato modernità anche nel decidere l’uscita di scena”, e hanno elogiato la coerenza della parola mantenuta, come se il mantenere una promessa di morte fosse meritevole di plauso. Taluni titoli, in un umorismo nero malamente celato, hanno addirittura commentato che “hanno tracciato una linea vivace e definitiva”, come se la definitiva scomparsa potesse essere descritta con un aggettivo di giubilo.
Non è mancata la voce di quotidiani che hanno cercato una cornice concettuale: Avvenire ha denunciato uno “spettacolo della morte”, parlando dell’“ultima esibizione” nel registro sorprendente di una testata confessionale; il Messaggero ha evocato la nozione di “morte ipermoderna”, proponendo la vicenda come paradigma di una società che rimuove e scarta. In mezzo a questa coralità di toni entusiasti si è levata una nota dissonante: Iva Zanicchi ha ricordato con nettezza la sacralità della vita e la necessità d’affrontarla sino in fondo, posizione che suona come un’alzata di voce contro la festosa normalizzazione della dipartita.
Il dolore rimosso e la cultura dell’anestesia
Tale ostentazione è il riflesso d’una condizione culturale più vasta: una civiltà che teme la sofferenza e preferisce rimuoverla anziché accoglierla. Quando la fragilità viene cancellata dall’orizzonte comunitario, quando il patire diventa fardello da cui disfarsi, l’orizzonte morale si assottiglia e la morte può apparire come rimedio. Pensatori contemporanei, Byung-Chul Han, Giorgio Agamben e Massimo Cacciari, hanno richiamato la necessità di riaprire il dialogo con la trascendenza e la metafisica per riaccendere il senso che l’homo occidentalis pare aver smarrito.
Il caso delle Kessler è esemplare di un dramma privato che si fa paradigma sociale: l’isolamento degli anziani, l’assenza di legami che diano continuità, la mancanza di eredi affettivi e di reti di cura. Non sempre è la sofferenza fisica a spingere verso l’estremo; spesso è il peso di una solitudine che cancella il futuro e rende ogni mattino un’ombra più lunga.
Contro la glorificazione della morte
Non possiamo, con cuore sereno, applaudire la morte quando questa si presenta come rito ben confezionato. La celebrazione mediatica di questo commiato tradisce la pietà: glorificare l’atto del morire come indice di modernità equivale a legittimare la sospensione della cura e a favorire una cultura che decreta il fragile come scarto ineluttabile.
Chiniamo il capo davanti alla memoria di due donne che furono canto e danza, ma rifiutiamo la loro strumentalizzazione. Il compito morale di una civiltà degna è custodire il dolore altrui, sottrarlo al consumo e restituirgli la dignità che gli compete, lontano dalle luci d’un palcoscenico che non distingue più tra bellezza e devastazione.