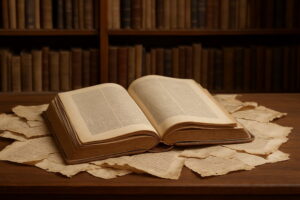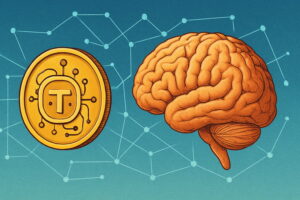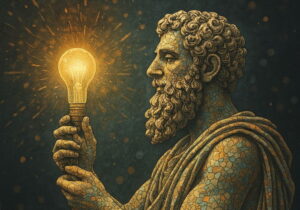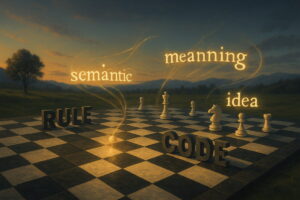L’Europa non è stata sconfitta ieri a Washington. È da anni che si è auto-condannata alla marginalità. Non sono stati Trump, Putin o Xi a relegarci a spettatori: è stata la nostra incapacità di pensarci come soggetto politico e non soltanto come mercato.
Quella che chiamiamo “Unione Europea” non è una federazione di popoli, non è uno Stato, non è neppure una confederazione: è un ibrido tecnocratico costruito senza una vera carta costituzionale, privo di una volontà popolare fondativa. Un corpo senz’anima che vive di regolamenti e di vincoli e, nel frattempo, soffoca l’impresa e smorza la decisione.
Il paradosso è sotto gli occhi: più regole, meno potenza. Si è scambiata la moltiplicazione della burocrazia per integrazione politica. Si è preferita la gabbia regolativa alla sovranità continentale.
La genealogia di un fallimento
Per capire come ci siamo arrivati bisogna tornare all’origine. La CEE nasce nel 1957 come risposta occidentale alla sfida sovietica, dentro l’ombrello atlantico ma con un margine di autonomia strategica. Era il capitalismo renano che discuteva – e in parte sfidava – quello anglosassone: industria manifatturiera, cooperazione tra capitale e lavoro, pianificazione indicativa. Un terzo modello fra il dirigismo sovietico e il liberismo americano.
Quel progetto poggiava su una base materiale chiara: la ricostruzione industriale europea del secondo dopoguerra, alimentata dal Piano Marshall ma orientata all’autosufficienza continentale. Era la stagione dei campioni nazionali e delle politiche industriali: l’IRI, la planification francese, il Wirtschaftswunder tedesco, i poli di sviluppo. L’integrazione economica funzionava perché serviva i progetti nazionali di modernizzazione; non pretendeva di sostituirli.
Il punto di rottura coincide con il collasso di Bretton Woods e l’avvento della globalizzazione finanziaria. Di fronte al cambio d’epoca, l’Europa, invece di dotarsi di un proprio sistema monetario sovrano e di un indirizzo industriale comune, imbocca la strada dell’adeguamento: Serpente monetario, SME, euro. A ogni passaggio si approfondisce l’integrazione dei mercati finanziari e si restringe l’autonomia delle politiche industriali. È la nascita di un’Unione monetaria senza Stato: perfetta per controllare i saldi, incapace di generare decisione strategica.
Il tradimento delle élite
Lo spartiacque politico è Maastricht. Non solo per i parametri di convergenza, ma per l’impostazione: l’Europa come spazio di regole, non come spazio di progetto. Qui matura il tradimento delle élite: classi dirigenti che abdicano alla sovranità in cambio di una governance che promette stabilità e offre, in realtà, eteronomia. È l’egemonia ordoliberale: prima le regole, poi – forse – i progetti. Una grande Svizzera: neutrale, ordinata, irrilevante.
Le conseguenze si vedono quando scoppiano le crisi. Alla grande crisi del 2008 gli Stati Uniti rispondono con espansione fiscale e reshoring industriale; l’Europa imbocca l’austerità e perfeziona il proceduralismo. La Cina lancia corridoi, porti, reti energetiche; l’Europa affina linee guida e meccanismi. La Russia torna a pensarsi come impero; l’Europa coltiva l’illusione del soft power come surrogato della potestas.
La resa geopolitica sull’Ucraina
La guerra in Ucraina ha solo reso visibile ciò che era già scritto: la strategia si formula altrove e l’Europa è convocata a cose fatte. Non partner, ma platea. Non attori, ma comparse. Il negoziato vero si consuma nei bilaterali tra Washington e Mosca; a Bruxelles restano il commento e il finanziamento. Non siamo irrilevanti perché esclusi: siamo esclusi perché irrilevanti.
La lezione è brutale: senza sovranità energetica, senza difesa autonoma, senza una classe politica capace di comporre interessi nazionali in una volontà continentale, il vincolo esterno diventa abisso interno. E si finisce clienti dell’impero: non decidiamo, paghiamo.
Un armistizio europeo?
Il modo in cui finirà la guerra in Ucraina ha un precedente storico. Nel 1953 la guerra di Corea si concluse non con un vincitore e un vinto, ma con un armistizio che congelò il fronte lungo il 38° parallelo. Nessuna pace formale, un compromesso imposto dalle grandi potenze – Stati Uniti, URSS, Cina – che ridefinirono l’ordine asiatico senza che né Seul né Pyongyang avessero realmente voce.
È plausibile che lo stesso schema si ripeta in Europa orientale: una linea di confine trasformata in “provvisorio permanente”, un conflitto congelato ma non risolto. Una pace fredda, più che una pace giusta.
La differenza, però, è essenziale: la Corea del Sud, sotto l’ombrello americano, ha potuto trasformarsi in potenza industriale e tecnologica. L’Europa, invece, rischia di restare un protettorato allargato, ricco ma impotente, spettatore della propria periferia incendiata.
Ecco la vera domanda: l’Europa vuole accettare di diventare la Corea del XXI secolo, con eserciti di altri sul proprio territorio e strategie decise altrove? O vuole finalmente assumersi la responsabilità di un compromesso che nasca anche da una volontà politica europea?
L’assenza del conflitto
C’è un tratto che raramente si coglie: l’Europa ha espulso il conflitto dalla propria architettura. Quello militare, delegato alla NATO; quello sociale, consegnato alla mediazione tecnica. Ma non esiste costruzione statuale senza conflitto costituente. Stati Uniti, Germania, Francia: ognuno ha attraversato una frattura fondativa. L’Europa ha tentato di saltarla, inseguendo l’utopia post-politica degli interessi sempre componibili.
Per questo, a ogni crisi – migrazioni, energia, pandemia, guerre di confine – l’Unione si decompone nelle sue parti. Non per egoismo: per assenza di principio politico.
La lezione dell’Oriente
Mentre noi perfezionavamo il regolamento, l’Asia praticava il progetto. La Belt and Road non è un mercato unico; è un mosaico di opere. L’ASEAN non finge unione statuale; costruisce cooperazione variabile. Interdipendenze funzionali, non sovrastrutture giuridiche. Un pragmatismo che parla la lingua che abbiamo smesso di intendere: la lingua dell’interesse nazionale che si fa alleanza concreta.
Il ritorno al consorzio
L’alternativa, dunque, non è un’utopia: è un ritorno al consorzio. Non l’ennesima riforma dei Trattati, ma cantieri comuni in pochi assi: difesa, energia, aerospazio, microelettronica. Non tutto insieme, non tutti con tutti, ma cooperazione a geometria variabile con equa ripartizione dei benefici. È l’Europa che funziona quando fa: Airbus ed Eurofighter, ESA/Galileo, CERN. Ogni volta che il continente ha pensato in termini di progetto industriale, ha saputo competere. Ogni volta che si è perso nella normativa senza finalità, ha arretrato.
Per evitare equivoci: i consorzi europei possono funzionare, ma non per inerzia. Airbus è un caso solido: leadership industriale e occupazionale, pur con inciampi (il programma A380 chiuso, l’A400M nato fra ritardi e extracosti). L’Eurofighter ha generato filiere ed export importanti, ma ha pagato la governance complessa e la rincorsa ai costi; è un successo industriale più che un collante strategico. Galileo oggi è operativo e offre servizi di precisione e di search & rescue, anche se ha attraversato ritardi e un blackout rilevante nel 2019: la dimostrazione che l’autonomia si conquista con pazienza, non con i comunicati. Il CERN, infine, è l’esempio di spillover che trascendono il settore: dalla fisica delle particelle all’innovazione generale, fino a invenzioni che hanno cambiato il mondo. La regola è semplice: il consorzio riesce quando è progetto con output misurabili; fallisce quando si fa processo senza scopo.
A chi obietta che l’Unione possiede già strumenti – fondi, atti, cornici – rispondo: cornici senza indirizzo strategico non sono politica industriale; sono amministrazione dell’esistente. Servono leader che dicano dove e perché investire, e poi costruiscano gli incentivi perché capitale e lavoro facciano il resto.
La questione della classe dirigente
È qui il punto: non è un problema di architettura soltanto, è un problema di classe dirigente. In trent’anni abbiamo allevato ceti politici formati al culto del vincolo esterno: l’Europa come alibi per non scegliere. Servono persone capaci di radicamento nazionale e visione continentale, che sappiano che l’Europa non è un destino ma un progetto, non un’eredità ma una conquista quotidiana.
Il tempo del realismo
La vera domanda non è “più o meno Europa”. La vera domanda è: Europa-consorzio che decide, o Europa-mercato che subisce? Senza una generazione di leader che unisca visione storica, responsabilità industriale e autonomia strategica, nessun modello reggerà. Come scriveva Carl Schmitt, «sovrano è colui che decide sullo stato di eccezione». L’Europa ha smesso di decidere; per questo è diventata irrilevante.
Il tempo del realismo è adesso. O l’Europa ritrova la politica – e con essa la capacità di progetto – oppure la politica troverà altre strade. E noi resteremo, ancora, ospiti paganti al tavolo della storia.