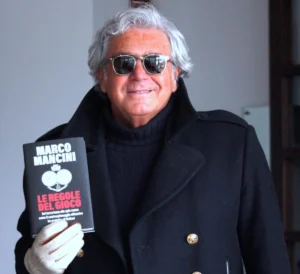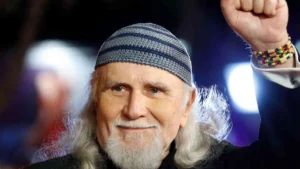Sono passati sei mesi da quel pomeriggio dell’8 maggio quando il nuovo Vescovo di Roma, primo Papa statunitense e agostiniano, si è affacciato dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro. C’è un filo rosso che attraversa il suo magistero ed è quello di una Chiesa segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato di fronte alle guerre, all’odio e alle violenze. Al di là delle analisi sugli accenti di continuità e di discontinuità con il predecessore (naturali in ogni pontificato), vale la pena ripercorrere alcune tappe di questo magistero, che evidenziano come l’annuncio dell’essenziale della fede non sia mai disgiunto dalla testimonianza della carità, dall’impegno concreto in favore degli ultimi e per la costruzione di una società più giusta. Fin dalle sue prime parole, pronunciate nel saluto subito dopo l’elezione: “La pace sia con tutti voi! (…) Questa è la pace del Cristo Risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionatamente. (…) Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta ad accogliere”. Una Chiesa, ha detto nell’omelia della Messa per l’inizio del pontificato il 18 maggio 2025, “unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. In questo nostro tempo, vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall’odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della Terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere, dentro questa pasta, un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità”.
Al cuore della missione: sparire perché rimanga Cristo
Il giorno dopo l’elezione, nella prima celebrazione con i cardinali nella Cappella Sistina, Leone XIV ha richiamato un “impegno irrinunciabile per chiunque nella Chiesa eserciti un ministero di autorità: sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato, spendersi fino in fondo perché a nessuno manchi l’opportunità di conoscerlo e amarlo”. Nell’omelia del 18 maggio, il Papa ha parlato di “amore e unità” come delle due dimensioni affidate da Gesù a Pietro e ha spiegato che questo compito è possibile solo perché Pietro “ha sperimentato nella propria vita l’amore infinito e incondizionato di Dio, anche nell’ora del fallimento e del rinnegamento”. Perché, come ha detto ai giovani radunati a Tor Vergata la sera del 2 agosto, “all’origine di noi stessi non c’è stata una nostra decisione, ma un amore che ci ha voluti”. Questo amore ci precede, come ha spiegato il Papa nella catechesi all’udienza di mercoledì 20 agosto, parlando di Giuda che riceve il boccone di pane da Gesù all’Ultima Cena: “Gesù porta avanti e a fondo il suo amore (…) Perché sa che il vero perdono non aspetta il pentimento, ma si offre per primo, come dono gratuito, ancor prima di essere accolto”.
La missione della Chiesa è testimoniare questo amore. Per farlo, ha spiegato Leone il 7 giugno 2025 durante la veglia di Pentecoste, “non occorrono sostenitori potenti, compromessi mondani, strategie emozionali. L’evangelizzazione è opera di Dio e, se talvolta passa attraverso le nostre persone, è per i legami che rende possibili”. Alla Chiesa non servono scambi di favori con il mondo, ma nemmeno strategie di marketing che fanno leva sulle emozioni o sull’eccesso di protagonismo. L’evangelizzazione infatti è Dio che opera. Fondamentale per la missione è l’unità nella diversità, cioè la comunione vissuta. È una fede, come ha sottolineato domenica 5 ottobre 2025 celebrando il Giubileo del mondo missionario, che “non si impone con i mezzi della potenza e in modi straordinari; ne basta quanto un granello di senape per fare cose impensabili, perché reca in sé la forza dell’amore di Dio che apre vie di salvezza. È una salvezza che si realizza quando ci impegniamo in prima persona e ci prendiamo cura, con la compassione del Vangelo, della sofferenza del prossimo”.
La fede proposta da Leone XIV nell’omelia del 29 giugno, è attenta al “rischio di cadere nell’abitudine, nel ritualismo, in schemi pastorali che si ripetono senza rinnovarsi e senza cogliere le sfide del presente”, ed è capace di “lasciarsi interrogare dagli avvenimenti, dagli incontri e dalle situazioni concrete delle comunità, di cercare strade nuove per l’evangelizzazione a partire dai problemi e dalle domande posti dai fratelli e dalle sorelle nella fede”. È una fede che non giudica gli altri, che non ci fa sentire “perfetti”, anche perché, come ha spiegato all’Angelus di domenica 24 agosto, Gesù mette in crisi “la sicurezza dei credenti”: “Egli, infatti, ci dice che non basta professare la fede con le parole, mangiare e bere con Lui celebrando l’Eucaristia o conoscere bene gli insegnamenti cristiani. La nostra fede è autentica quando abbraccia tutta la nostra vita, quando diventa un criterio per le nostre scelte, quando ci rende donne e uomini che si impegnano nel bene e rischiano nell’amore proprio come ha fatto Gesù”. I cristiani infatti, ha detto il Papa all’udienza generale del 3 settembre, sono testimoni di un Dio che sulla croce “non appare come un eroe vittorioso, ma come un mendicante d’amore. Non proclama, non condanna, non si difende. Chiede, umilmente, ciò che da solo non può in alcun modo darsi (…) Questo è il paradosso cristiano: Dio salva non facendo, ma lasciandosi fare. Non vincendo il male con la forza, ma accettando fino in fondo la debolezza dell’amore. Sulla croce, Gesù ci insegna che l’uomo non si realizza nel potere, ma nell’apertura fiduciosa all’altro, persino quando ci è ostile e nemico”.
Testimoniare la pace
Dopo averlo fatto in quel primo saluto il giorno dell’elezione, Leone XIV ha parlato moltissime volte di pace, invitando i cristiani a testimoniarla concretamente: “La nonviolenza come metodo e come stile deve contraddistinguere le nostre decisioni, le nostre relazioni, le nostre azioni” ha detto il 30 maggio ai movimenti e associazioni dell’Arena della pace. E ai vescovi italiani il 17 giugno 2025 ha chiesto “che ogni Diocesi possa promuovere percorsi di educazione alla nonviolenza, iniziative di mediazione nei conflitti locali, progetti di accoglienza che trasformino la paura dell’altro in opportunità di incontro”.
Allo stesso tempo, il Successore di Pietro ha alzato più volte la sua voce contro il riarmo, come ha fatto alla fine dell’udienza il 18 giugno: “Non dobbiamo abituarci alla guerra! Anzi, bisogna respingere come una tentazione il fascino degli armamenti potenti e sofisticati”. Leone XIV ha parlato delle fake news usate come pretesto per attacchi preventivi o per scatenare nuove guerre, come ha fatto il 26 giugno ricevendo i partecipanti della ROACO, la Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali: “Siamo chiamati noi tutti, umanità, a valutare le cause di questi conflitti, a verificare quelle vere e a cercare di superarle, e a rigettare quelle spurie, frutto di simulazioni emotive e di retorica, smascherandole con decisione. La gente non può morire a causa di fake news”. In quello stesso discorso anche un passaggio caratterizzato da un grande realismo e senso della storia, quella memoria che molti oggi sembrano aver perduto: “Come si può credere, dopo secoli di storia, che le azioni belliche portino la pace e non si ritorcano contro chi le ha condotte? (…) Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo, nella vana illusione che la supremazia risolva i problemi anziché alimentare odio e vendetta? La gente è sempre meno ignara della quantità di soldi che vanno nelle tasche dei mercanti di morte e con le quali si potrebbero costruire ospedali e scuole; e invece si distruggono quelli che sono già costruiti!”.
Il disarmo chiesto dal Vescovo di Roma riguarda sia i governanti delle nazioni affinché non trasformino la ricchezza “contro l’uomo, trasformandola in armi che distruggono i popoli e in monopoli che umiliano i lavoratori” (omelia di domenica 21 settembre nella parrocchia di sant’Anna in Vaticano), sia ciascuno di noi, perché l’invito di Gesù è a disarmare la mano ma prima di tutto il cuore. Come Leone ha affermato al termine della Veglia mariana per la pace sabato 11 ottobre 2025: “Metti via la spada è parola rivolta ai potenti del mondo, a coloro che guidano le sorti dei popoli: abbiate l’audacia del disarmo! Ed è rivolta al tempo stesso a ciascuno di noi, per farci sempre più consapevoli che per nessuna idea, o fede, o politica noi possiamo uccidere. Da disarmare prima di tutto è il cuore, perché se non c’è pace in noi, non daremo pace”. È l’invito “ad acquisire un punto di vista diverso per guardare il mondo dal basso, con gli occhi di chi soffre, non con l’ottica dei grandi”.
Leone, il 9 ottobre, nel discorso alla Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre, ha anche spiegato, che “nessuna pace è possibile laddove non c’è libertà religiosa o dove non c’è libertà di pensiero e di parola e il rispetto delle opinioni altrui”.
L’amore ai poveri
Nella sua prima esortazione apostolica, Dilexi te, pubblicata il 9 ottobre, Papa Leone ha spiegato che aiutando chi soffre “non siamo nell’orizzonte della beneficenza, ma della Rivelazione: il contatto con chi non ha potere e grandezza è un modo fondamentale di incontro con il Signore della storia”. L’amore ai poveri non è un “percorso opzionale”, ma rappresenta “il criterio del vero culto”. “Il fatto che l’esercizio della carità risulti disprezzato o ridicolizzato, come se si trattasse della fissazione di alcuni e non del nucleo incandescente della missione ecclesiale, mi fa pensare che bisogna sempre nuovamente leggere il Vangelo, per non rischiare di sostituirlo con la mentalità mondana”. Ed “è compito di tutti i membri del Popolo di Dio far sentire una voce che svegli, che denunci, che si esponga”. Anche a costo di sembrare “stupidi”.
Leone ha spiegato, nella catechesi dell’udienza generale del 28 maggio, che “la pratica del culto non porta automaticamente ad essere compassionevoli. Infatti, prima che una questione religiosa, la compassione è una questione di umanità! Prima di essere credenti, siamo chiamati a essere umani”. Incontrando i nunzi apostolici, il 10 giugno 2025, il Papa ha detto loro: “Conto su di voi affinché nei Paesi dove vivete tutti sappiano che la Chiesa è sempre pronta a tutto per amore, che è sempre dalla parte degli ultimi, dei poveri, e che sempre difenderà il sacrosanto diritto a credere in Dio (…) Solo l’amore è degno di fede, di fronte al dolore degli innocenti, dei crocifissi di oggi”. E il 13 luglio da Castelgandolfo ha invitato, seguendo l’esempio del Buon Samaritano, a non “passare oltre” ma a lasciarci “trafiggere il cuore” da “tutti coloro che sprofondano nel male, nella sofferenza e nella povertà”, da “tanti popoli spogliati, derubati e saccheggiati, vittime di sistemi politici oppressivi, di un’economia che li costringe alla povertà, della guerra che uccide i loro sogni e le loro vite”. Definendo le opere di misericordia, come ha fatto il 10 agosto all’Angelus, “la banca più sicura e redditizia dove affidare il tesoro della nostra esistenza (…) in famiglia, in parrocchia, a scuola e nei luoghi di lavoro, ovunque siamo, cerchiamo di non perdere nessuna occasione per amare”.
Il Papa, al Giubileo degli operatori di giustizia, il 20 settembre, ha invitato a non distogliere lo sguardo dalla “realtà di tanti Paesi e popoli che hanno fame e sete di giustizia, perché le loro condizioni di vita sono talmente inique e disumane da risultare inaccettabili”, ricordando che “lo Stato, in cui non si ha la giustizia, non è uno Stato”. Parlando ai Movimenti popolari, il 23 ottobre 2025, il Successore di Pietro ha ricordato che “l’esclusione è il nuovo volto dell’ingiustizia sociale. Il divario tra una “piccola minoranza” – l’1% della popolazione – e la stragrande maggioranza si è ampliato in modo drammatico. (…) Come Vescovo in Perù, sono felice di aver sperimentato una Chiesa che accompagna le persone nei loro dolori, nelle loro gioie, nelle loro lotte e nelle loro speranze. Questo è un antidoto contro un’indifferenza strutturale che si va diffondendo e che non prende sul serio il dramma di popoli spogliati, derubati, saccheggiati e costretti alla povertà”.
I migranti nostri fratelli
Leone XIV, nell’omelia per il Giubileo del Mondo missionario e dei migranti, domenica 5 ottobre ha parlato della “storia di tanti nostri fratelli migranti, il dramma della loro fuga dalla violenza, la sofferenza che li accompagna, la paura di non farcela, il rischio di pericolose traversate lungo le coste del mare, il loro grido di dolore e di disperazione: fratelli e sorelle, quelle barche che sperano di avvistare un porto sicuro in cui fermarsi e quegli occhi carichi di angoscia e speranza che cercano una terra ferma in cui approdare, non possono e non devono trovare la freddezza dell’indifferenza o lo stigma della discriminazione!”. E nel discorso ai Movimenti popolari del 23 ottobre ha parlato del tema della sicurezza: “Gli Stati hanno il diritto e il dovere di proteggere i propri confini, ma ciò dovrebbe essere bilanciato dall’obbligo morale di fornire rifugio. Con l’abuso dei migranti vulnerabili, non assistiamo al legittimo esercizio della sovranità nazionale, ma piuttosto a gravi crimini commessi o tollerati dallo Stato. Si stanno adottando misure sempre più disumane – persino politicamente celebrate – per trattare questi ‘indesiderabili’ come se fossero spazzatura e non esseri umani. Il cristianesimo, invece, si riferisce al Dio amore, che ci rende fratelli tutti e ci chiede di vivere da fratelli e sorelle”.
Conversione per custodire il Creato
Più volte il Papa ha parlato della custodia del Creato, sulla scia dell’enciclica “Laudato si’” del predecessore Francesco. Come ha fatto il 9 luglio, introducendo la “Messa per il Creato”: “All’inizio della Messa abbiamo pregato per la conversione, la nostra conversione. Vorrei aggiungere che dobbiamo pregare per la conversione di tante persone, dentro e fuori della Chiesa, che ancora non riconoscono l’urgenza di curare la casa comune. Tanti disastri naturali che ancora vediamo nel mondo, quasi tutti i giorni in tanti luoghi, in tanti Paesi, sono in parte causati anche dagli eccessi dell’essere umano, col suo stile di vita. Perciò dobbiamo chiederci se noi stessi stiamo vivendo o no quella conversione: quanto ce n’è bisogno!”.
Fonte: vaticannews.it