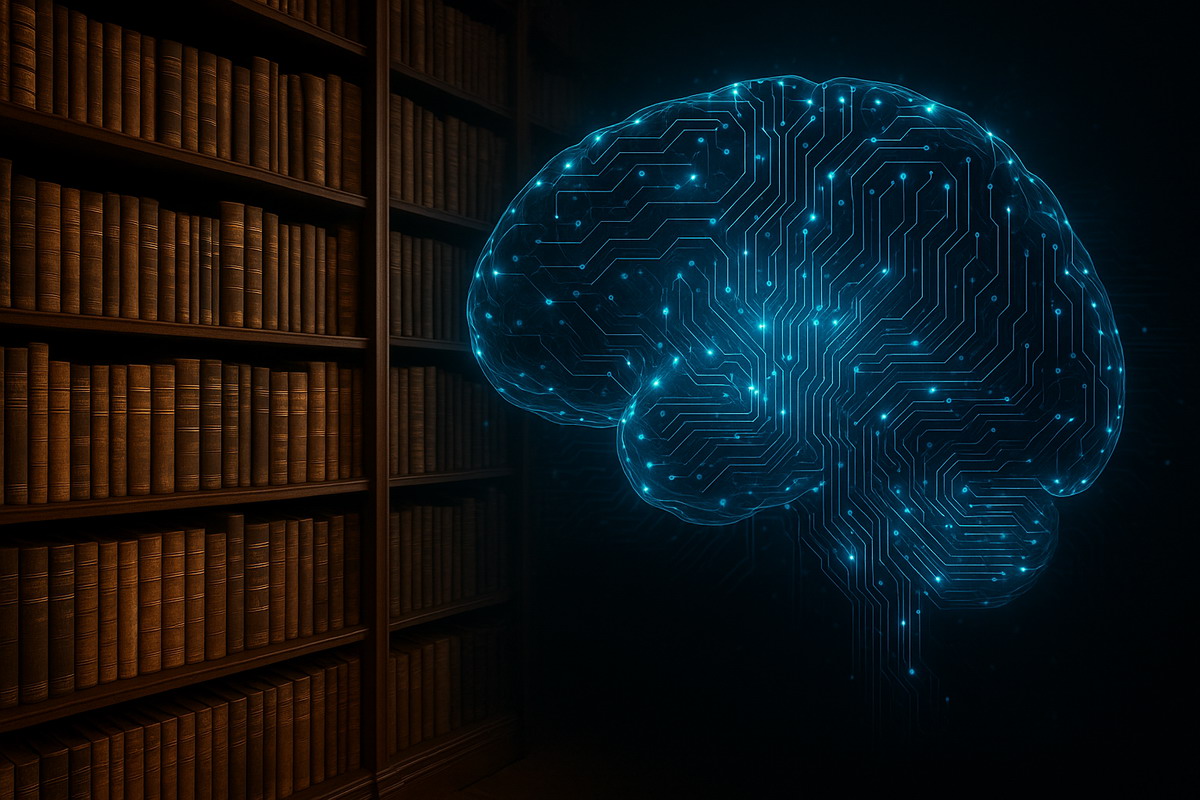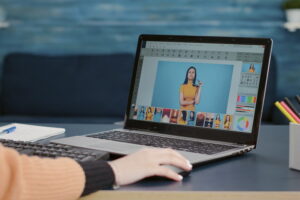C’è chi pensa che l’Intelligenza Artificiale sia nata nel 2022, con lo scalpore mediatico di ChatGPT. Un po’ come se la scoperta dell’America fosse merito dei tour operator, dimenticando caravelle e bussole. Eppure, l’IA affonda le sue radici in un terreno coltivato per decenni: le scienze cognitive. Una trama di saperi intrecciati – filosofia, psicologia, linguistica, neuroscienze, informatica – che hanno tentato, con un misto di rigore e follia, di rispondere a una domanda ostinata: come funziona la mente umana, e possiamo replicarla?
Non è un caso che Norbert Wiener, il padre della cibernetica, avesse avvertito già nel 1967: “Il mondo del futuro sarà una lotta sempre più impegnativa contro i limiti della nostra intelligenza, non una comoda amaca servita dai nostri schiavi robot.” Visione profetica, che oggi suona come un ammonimento.
L’onda lunga della società dell’informazione
Già negli anni ’90, nei corridoi delle università di linguistica computazionale, circolavano due profezie inquietanti: la società sarebbe stata plasmata dall’esponenziale pervasività delle tecnologie dell’informazione, e l’incapacità della maggior parte degli individui di gestire l’overload informativo sarebbe diventata un’emergenza globale. Entrambe si sono avverate.
Oggi viviamo nell’Infosfera, per usare la definizione di Luciano Floridi, e persino l’Oxford Languages nel 2024 ha scelto come parola dell’anno “brain rot”, il marciume cognitivo da eccesso di contenuti. Siamo dunque la prima civiltà che rischia di soffocare non per mancanza di dati, ma per la loro ridondanza.
Le radici: tra Lurija, Chomsky e Shannon
Negli anni ’50 Aleksandr Lurija, neuropsicologo sovietico, dimostrava con i suoi esperimenti quanto fosse intricato il legame fra cervello e mente. Contemporaneamente, a Boston, Noam Chomsky proponeva la grammatica generativa: un’idea rivoluzionaria che spazzava via il vecchio strutturalismo e apriva la strada alla comprensione formale del linguaggio. Non bastava più descrivere le frasi: bisognava capire le regole profonde che le generano.
Claude Shannon, invece, scriveva A Mathematical Theory of Communication, fondando la teoria dell’informazione. Con quel celebre schema – sorgente, trasmettitore, segnale, ricevitore, destinazione, e l’intrusione del “rumore” – egli offrì una bussola che ancora oggi, in piena era GenAI, continua a orientare ingegneri e filosofi.
Tre voci, tre discipline. Insieme disegnavano i primi tratti di quel grande puzzle interdisciplinare che avrebbe preso il nome di scienze cognitive.
Il battesimo dell’IA: Dartmouth, estate 1956
Fu però nell’estate del 1956 che la parola Artificial Intelligence venne pronunciata per la prima volta. Al Dartmouth College, nel New Hampshire, un gruppo di giovani ricercatori – John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, Claude Shannon – organizzò un seminario che si proponeva un obiettivo ardito: programmare computer capaci di ragionare, percepire e generalizzare conoscenze come gli esseri umani.
Con un candore che oggi ci fa sorridere, pensarono che sarebbero bastati un paio di mesi di brainstorming. Sessantotto anni dopo, siamo ancora qui a provarci. Ma è proprio da quella sfrontatezza che nacque una disciplina nuova, destinata a cambiare il mondo.
Il lungo cammino: tra primavere e inverni
Il percorso dell’IA non è stato lineare. Karl Popper teorizzava la scienza come un gioco di congetture e confutazioni. Hilary Putnam sviluppava la teoria computazionale della mente. John Searle, con la sua “stanza cinese”, provocava la comunità accademica sul tema della coscienza artificiale. Sembrano digressioni filosofiche, ma in realtà erano tasselli indispensabili: la dimostrazione che per parlare di intelligenza, naturale o artificiale, non si può prescindere da filosofia, linguistica e neuroscienze.
Il campo ha conosciuto anche i suoi “inverni” – periodi di disillusione e tagli ai finanziamenti negli anni ’70 e ’80 – quando le promesse iniziali si scontrarono con i limiti tecnologici dell’epoca. Ogni crisi, però, ha portato a una maturazione: dall’approccio simbolico agli algoritmi di apprendimento, dalle reti neurali al machine learning contemporaneo.
Dall’utopia all’attualità: il filo rosso che unisce passato e presente
Arriviamo così al presente. Nel 2022, con il lancio pubblico di ChatGPT, la società globale ha percepito l’IA come un fenomeno improvviso. Ma è un’illusione ottica: dietro ogni prompt digitato c’è mezzo secolo di esperimenti, modelli e fallimenti. Non è un Big Bang, ma una lunga gestazione.
L’IA generativa di oggi, con le sue capacità linguistiche e creative, non è che la prosecuzione – in forma amplificata – delle intuizioni di Chomsky e Shannon. Quando ChatGPT genera un testo coerente, sta applicando pattern linguistici che riflettono le “regole profonde” teorizzate dal linguista del MIT. Quando elabora informazioni rumorose o incomplete, utilizza principi di correzione dell’errore che derivano direttamente dalla teoria dell’informazione di Shannon.
Una sfida culturale prima che tecnologica
Se è vero, come ricordava Eco, che ogni epoca è definita dai suoi strumenti di memoria (dalla pergamena al web), allora l’IA rappresenta la nuova “biblioteca di Babele”. Una biblioteca che non si limita a contenere, ma inventa testi su richiesta. Come nella visione di Borges, questa biblioteca infinita contiene ogni possibile combinazione di parole: verità e falsità, capolavori e sciocchezze, tutto mescolato in un labirinto di possibilità.
E la domanda diventa: saremo capaci di discernere il vero dal verosimile, l’utile dal superfluo? La sfida dell’IA non è soltanto tecnica, ma cognitiva e culturale. Sta a noi decidere se usarla come un’estensione della nostra intelligenza o come una protesi che ci atrofizza.
L’eredità da custodire: integrare saggezza e algoritmi
L’intelligenza artificiale non nasce oggi, ma da un lungo percorso che attraversa università, laboratori e biblioteche del Novecento. Conoscere quella genealogia significa capire che non siamo davanti a una magia, bensì a una costruzione storica e collettiva.
Il futuro dell’IA non dipenderà solo dagli algoritmi, ma da come sapremo integrare in essa la saggezza delle scienze cognitive. Questo significa, concretamente, progettare sistemi che non solo elaborino informazioni, ma comprendano il contesto come facevano gli esperimenti di Lurija; che non solo generino linguaggio, ma rispettino le strutture profonde studiate da Chomsky; che non solo trasmettano dati, ma sappiano filtrare il rumore come insegnava Shannon.
Perché, come ammoniva Wiener, la vera battaglia del futuro sarà contro i limiti della nostra intelligenza – non contro le macchine che costruiamo, ma insieme a esse, in una partnership che richiede tutta la nostra saggezza storica per essere fruttuosa.